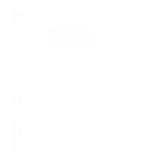Sandro Lovari, senese classe 1946, appartiene a una generazione di grandi etologi italiani, in compagnia di nomi illustri come Danilo Mainardi, Floriano Papi, Leo Pardi.
Ha girato il mondo negli ultimi decenni per condurre ricerche su animali iconici come le tigri o i leopardi. Altre su soggetti meno conosciuti ma ugualmente interessanti come i grandi erbivori che popolano le montagne della catena himalayana.
Ci incontriamo nel suo studio a Siena. Da una lunga intervista emerge una carriera ricca di avventure e viaggi, ma non solo. Anche una preoccupazione per il futuro dell’etologia e per il ruolo della tecnologia nelle scienze naturali.
Prima di recarci nel bell’orto botanico dove faremo la nostra chiacchierata, mi saltano all’occhio alcuni dettagli dello studio. Come una grande mappa dell’Asia, continente a cui è particolarmente legato, ma anche un ritratto di Charles Darwin. Poco più in basso, una sua foto in compagnia di un altro grande etologo dei nostri tempi, George B. Schaller. A ricordarci che anche i nostri maestri hanno avuto, a loro volta, i loro punti di riferimento. Gli chiedo di raccontarmi di lui.
L’ESEMPIO DI SCHALLER
«Ho incontrato George Schaller l’ultima volta a Pechino un anno fa: un giovincello di 86 anni, ma pieno di energia. Stimo alcune persone, ma ne ammiro una sola, ed è lui. È stato ed è un punto di riferimento e stimolo per me e per altri. Era già noto quando io avevo appena finito l’università. Il suo primo libro sul gorilla di montagna uscì infatti nella seconda metà degli anni Sessanta e io mi sono laureato nel 1972.
Per me George ha avuto un fondamentale ruolo di riferimento. Sa fare belle foto. Ha un modo di scrivere semplice ma efficace. Ha il grande talento di riuscire a decifrare il comportamento degli animali più disparati. Dal gorilla di montagna alla tigre e le sue prede, al leone, al panda maggiore. Poi il chiru, una sorta di capra tibetana che somiglia molto a un’antilope, e mille altri. Per tutti questi motivi ritengo Schaller una persona unica, fuori dal comune: l’ultimo grande esploratore naturalista… una sorta di leggenda vivente.
CORAGGIO DELLE PROPRIE OPINIONI
La caratteristica che me lo fa invece apprezzare come uomo è che dice schiettamente quello che pensa. Se fai o dici qualcosa di sbagliato, una stupidaggine, lui sorridendo te la fa notare. Ho sempre apprezzato le persone che hanno il coraggio delle proprie opinioni. Non sopporto, ad esempio, l’anonimato. Nelle revisioni degli articoli che vengono mandati alle riviste scientifiche, spesso viene esplicitamente richiesto l’anonimato, ma io li firmo tutti.
Un maggiorenne ha il dovere morale di avere il coraggio delle proprie azioni. Se critico qualcosa che hai scritto tu, non posso e non devo nascondermi dietro all’anonimato. Non è serio. Oltretutto, se firmo, riesco più facilmente a evitare di essere ironico nelle critiche. Si è insomma più rispettosi del lavoro altrui, pur criticandolo. E le critiche servono a migliorarsi: certamente non fanno piacere, ma sono utili.»

IL PRIMO INCONTRO
Quando lo hai incontrato la prima volta?
«Gli scrissi nel 1972 per chiedergli se potevo fare il dottorato con lui. Mi rispose con un biglietto postale, spedito dal cuore dell’Asia. Stava lavorando sugli erbivori della catena del Karakorum. Mi disse che non prendeva studenti per il suo tipo di ricerca, troppo rischiosa ai fini di un dottorato.
Rimasi colpito dal fatto che mi rispose: in fondo ero uno sconosciuto studentello e lui già uno scienziato molto famoso. Aveva cominciato giovanissimo: ricordo di essermi imbattuto in un suo articolo sul comportamento di pesca dei pellicani di metà anni Cinquanta. Quando lo scrisse doveva essere ancora uno studente alle prime armi.
Poi l’ho incontrato di persona la prima volta a Edmonton, se ben ricordo, nel 1985 a un congresso mondiale sui mammiferi. Mi è ancora capitato negli anni seguenti, a Hong Kong, in India e in Cina, ma lui tende a evitare i congressi, cosa che capisco benissimo. In quegli eventi sei circondato da persone che ti bombardano di domande, in un caos totale. I congressi scientifici, in realtà, sono soprattutto riunioni politiche e diplomatiche, fatte per conoscere persone.
Condivido la sua avversione, ma lui se lo poteva permettere, io no. Infatti li ho dovuti frequentare – pur con moderazione – e anche organizzare. Da diversi anni partecipo soltanto se mi interessano realmente, preferendo quelli ristretti e tematici a quelli generici.
Comunque, anche se ho incontrato Schaller non più di una decina di volte, ho sempre seguito il suo lavoro, letto tutti i suoi libri… sì, se esistesse uno Schaller fan club, probabilmente sarei il primo iscritto!»
GLI INIZI
(Ci rechiamo nell’orto botanico per iniziare l’intervista vera e propria, in un imprevisto nugolo di zanzare che ci tengono compagnia.)
Per quanto la tua carriera sia legata al lavoro sul campo, hai iniziato facendo ricerca in laboratorio. Nello specifico a Cambridge, nel gruppo di ricerca di Robert A. Hinde. A cosa è servita quell’esperienza?
«Attraverso le esperienze di laboratorio ho imparato quanto sia importante giungere a conclusioni frutto di esperimenti e poterle quantificare con numeri, in grafici e tabelle.
L’etologia, per la maggior parte delle persone, è andare in giro a fotografare animali o osservarli con il binocolo. Questa è solo la parte promozionale, la punta dell’iceberg. In realtà è una scienza come tutte le altre, che usa lo stesso approccio e le stesse finalità. Bisogna avere delle ipotesi in testa che vogliamo indagare.
È una disciplina dall’apparenza ingannevolmente semplice. In realtà è una scienza alla pari della microscopia elettronica, della medicina o della fisica, dove si fa molto uso della statistica. Questo l’ho imparato durante le mie permanenze a Cambridge, a Groninga e a Stoccolma.
In quei laboratori ho capito che la curiosità intellettuale del giovane deve essere incoraggiata, non tarpata. L’età giovanile è il periodo della vita in cui si apprende più facilmente. Per imparare, dobbiamo essere curiosi. “Tu non puoi capire” è la peggiore risposta che si possa dare a un bambino, a un adolescente. Magari non si potrà spiegare in dettaglio, ma non bisogna mai dare l’impressione che non ci sia una spiegazione.
Fare esperimenti in natura sui mammiferi è davvero molto complesso: con gli elefanti o con i bufali o con i leopardi è praticamente impossibile!
ETOLOGIA DA LABORATORIO
Quando si studia il comportamento animale in natura, è molto difficile organizzare esperimenti perché manca il controllo delle variabili ambientali. Il premio Nobel Nikolaas Tinbergen era bravissimo a fare brillanti esperimenti sul campo, e infatti non a caso dall’Olanda natìa lo chiamarono a Oxford.
Comunque anche i suoi esperimenti si articolavano sugli insetti, su uccelli al massimo, perché fare esperimenti in natura sui mammiferi è davvero molto complesso. Con gli elefanti, con i bufali o con i leopardi è praticamente impossibile! Bisogna allora osservare, raccogliere dati con metodo e poi formulare deduzioni, ma dove sia possibile fare esperimenti è sempre bene farli. Il valore dell’esperimento si apprende soprattutto in laboratorio.
Idealmente uno studio etologico dovrebbe partire da osservazioni di base condotte in natura. Dovrebbe poi essere trasportato in laboratorio dove si possono controllare le variabili ambientali. Infine, si dovrebbe reinterpretare tutto quello che abbiamo trovato di nuovo in natura, perché è lì che il comportamento di una specie si è evoluto.»

PROGETTI IN CORSO
Stai lavorando a un nuovo libro?
«Sì, mi mancano solo un paio di capitoli a terminarlo. Si intitolerà “Il leopardo dagli occhi di ghiaccio” per Laterza Editore. Farà riferimento alla biologia e conservazione del leopardo delle nevi.
È una specie che ho studiato per circa una quindicina d’anni in Nepal e in Pakistan. Tuttora me ne sto occupando in Tibet, in collaborazione con colleghi cinesi. Lo trovo un animale davvero affascinante, sia per l’ambiente aspro che frequenta, sia per la sua suggestiva bellezza.
È forse l’animale che mi piace di più. Il colore del suo mantello fa sognare, sembra quello delle montagne coperte di nubi e brume invernali. Gli occhi virano da un azzurro verdastro a un colore ocraceo. Ha una coda lunga tanto quanto il corpo. Questo perché gli deve consentire di mantenere l’equilibrio, come una sorta di timone, durante gli inseguimenti delle prede giù per i dirupi.
Una coda lunga disperde calore, però, e questo non è buono con temperature di -20 °C o anche più basse. Si rischierebbe il congelamento. Pertanto la coda è coperta da una pelliccia molto folta. È un animale affascinante per tanti aspetti e quindi ho deciso di dedicargli un libro. Anche se in realtà lo userò come leitmotiv. Parlerò anche dei risultati di altre mie ricerche, ad esempio sul leopardo comune, la tigre, l’elefante indiano.»
IL LEOPARDO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO
Proprio riguardo al leopardo delle nevi, che ricordi hai di questo animale?
«Sono sempre stato affascinato dalle culture e dalla fauna del continente asiatico. Ad assecondare questo mio interesse, venne un colpo di fortuna. Nel 1989 fui invitato a partecipare come zoologo alle ricerche dell’Everest-K2-CNR, un ente associato al CNR. Il progetto interessava il Parco Nazionale del monte Everest, il Sagarmatha National Park, in Nepal. Fu veramente un notevole colpo di fortuna. Le ricerche sono andate avanti per quasi 25 anni, espandendosi ad altre aree montane.
Quando cominciai a frequentare la Valle dell’Everest, l’unico grande mammifero facilmente osservabile risultò essere il tahr dell’Himalaya. Si trattava di una capra di alta montagna che nessuno aveva ancora studiato, tranne brevemente George Schaller venti anni prima. Decisi di concentrare l’attenzione su questa specie.
Nei primi anni del 2000, notai una particolarità: in autunno rimanevano pochissimi piccoli di quelli nati a inizio estate. Pensai che la causa potesse essere una malattia come la brucellosi o la tubercolosi, che possono ridurre la fecondità o indurre aborti. Qualcosa però non mi tornava perché in realtà i piccoli nascevano regolarmente. Allora chiesi di poter catturare una trentina di esemplari per fare un esame delle loro condizioni sanitarie. Con un gruppo di colleghi effettuammo prelievi di sangue e le analisi confermarono che la popolazione era sana.
Nel dicembre 2003, qualche giorno dopo che ero partito per l’Italia, un mio studente di dottorato, rimasto in Sagarmatha, vide un tahr addormentato. Era a una cinquantina di metri sotto il sentiero. Per capirne l’età si avvicinò, e si rese conto che in realtà l’animale non stava dormendo. Era la carcassa di un tahr adulto parzialmente mangiata. A dieci metri di distanza c’era un leopardo delle nevi, quello sì addormentato! Questo studente era piuttosto emotivo. Il timore che il leopardo si svegliasse, trovandolo accanto alla sua preda, lo indusse a fare solo poche foto, alquanto mosse. Ma il soggetto delle foto era ben riconoscibile!»

IL RITORNO NELLA VALLE DELL’EVEREST
«Ecco come scoprimmo che il leopardo delle nevi, che si era estinto nel Parco prima che questo venisse istituito negli anni Settanta, era tornato a frequentare quelle zone. In realtà, di quando in quando c’erano state segnalazioni di leopardi delle nevi. Ma erano probabilmente giovani maschi in fase di dispersione che non si fermavano, a causa dell’assenza di femmine. Infatti l’ultima femmina nel parco venne uccisa insieme ai suoi cuccioli a metà degli anni Sessanta. Agli inizi del 2000 devono essersi incontrati un maschio e una femmina durante la stagione degli amori, cominciando a riprodursi.
Dalle analisi fecali risultò che durante i mesi estivi il prelievo avveniva a carico soprattutto dei piccoli di tahr. Questi hanno un peso intorno a 30 kg, dunque i più facili da predare. Ecco perché i piccoli nascevano sempre nello stesso numero di prima, ma poi scomparivano durante l’estate!
Negli anni successivi i tahr cominciarono a diminuire di numero a causa della predazione mentre saliva quello dei leopardi. Successivamente cominciarono a diminuire anche i leopardi per la rarefazione delle prede, fino a stabilizzarsi in un equilibrio dinamico.
Raccoglievamo gli escrementi per conoscere la dieta del leopardo. Dall’analisi del DNA però scoprimmo che non c’era solo il leopardo delle nevi in quella valle, ma anche il leopardo comune. Immediatamente cercai di capire come queste due specie così simili potessero coesistere nella stessa area. La domanda di base era come si ripartissero l’habitat e le risorse alimentari e ne uscì uno studio che ha approfondito i rapporti predatore-predatore e predatore-preda.»
I PROBLEMI DELLA MONTAGNA
Uno degli ultimi studi a cui hai partecipato riguarda gli erbivori di montagna e il loro adattamento ai cambiamenti climatici. Qual è il messaggio di questo studio?
«Tra i mammiferi, il camoscio appenninico è stato il mio “primo amore”, fin dal lontano 1978. Su questa specie ho continuato a lavorare con relativa continuità per più di trent’anni. Nel 2007, tornai nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise dopo anni di assenza. Notai come nell’area storica di distribuzione di questa specie fosse cambiato qualcosa.
Quest’area, ricchissima di camosci negli anni Settanta-Ottanta, ospitava branchi dove mancavano ben tre classi di età. Erano assenti gli individui nati quattro, tre e due anni prima. Questo era molto insolito, anche perché i piccoli nati in quell’anno erano numerosi.
La prima ipotesi che mi venne in mente fu che i piccoli morissero a causa della competizione alimentare estiva con il cervo. Questo animale, infatti, era molto aumentato di numero e aveva colonizzato parzialmente, in qualche caso totalmente, l’area dove prima c’erano solo i camosci. Ci accorgemmo poi che, in realtà, la colpa non era tutta del cervo. Questo maestoso animale era sì coinvolto, ma agiva da catalizzatore di un fenomeno attivato dal cambio climatico in corso.
Nel nostro studio abbiamo trovato che c’è stato un aumento di circa due gradi nella temperatura media dell’Appennino centrale negli ultimi quarant’anni. Due gradi sono tantissimi e comportano l’anticipo di quasi un mese nella ricrescita della vegetazione novella in primavera.
Se la primavera si anticipa di un mese, sono guai seri per gli erbivori.
PRIMAVERA ANTICIPATA
L’aumento termico si manifesta soprattutto nelle temperature primaverili, mentre quelle invernali, autunnali ed estive sono rimaste più o meno inalterate. I piccoli di camoscio – come quelli di ogni specie di erbivoro – nascono in primavera. Questo perché il loro accrescimento corporeo deve avvenire quando il cibo è abbondante e la stagione propizia. In caso contrario, non crescono a sufficienza e poi non riescono a superare i rigori invernali.
Se la primavera si anticipa di un mese sono guai seri per gli erbivori. Così si anticipa anche il picco nella stagione vegetativa, quando le piante sono più nutrienti perché in crescita. I tessuti vegetali meristematici sono infatti particolarmente ricchi di risorse nutritive. Già un mese dopo, la qualità della vegetazione declina a causa del caldo, diventando più fibrosa.
Se i piccoli si svezzano su risorse alimentari povere non cresceranno a sufficienza. E, soprattutto, non costruiranno quelle preziose riserve di grasso necessarie per sopravvivere ai rigori invernali. Ne conseguirà un’alta mortalità e una destrutturazione della popolazione, che tenderà a estinguersi attraverso l’alta mortalità giovanile.
Le piante, vissute per qualche migliaio di anni in condizioni ambientali relativamente stabili, si trovano oggi a doversi confrontare con un clima che sta cambiando. Gli erbivori devono pertanto affrontare la diversa disponibilità di risorse alimentari.
Alcune associazioni vegetali si stanno spostando nelle cosiddette aree di rifugio, zone in cui sia ancora possibile trovare quelle condizioni per esse ideali. Altre specie più plastiche si adattano invece ai locali effetti del cambio climatico. Erbivori molto adattabili come i cervi non hanno grandi difficoltà ad adeguarsi. Quelli più specializzati come il camoscio o lo stambecco devono trovarsi aree di rifugio. Aree in cui passare qualche centinaio – o migliaio – di anni fino a quando le condizioni ambientali torneranno favorevoli.
Il problema si accresce quando le aree di rifugio non siano disponibili o […] non siano accessibili a causa di zone oggi fortemente antropizzate, che in passato non c’erano.
MIGRAZIONE VERSO L’ALTO
Il nostro studio nel Parco Nazionale d’Abruzzo ha mostrato come le associazioni vegetali elettive per i camosci siano scomparse gradualmente dalle montagne più basse. Per contro, sono invece aumentate su altre montagne, dove prima erano sporadicamente distribuite e dove ora le condizioni ambientali sono favorevoli. Il cervo interviene competendo con il camoscio per le risorse alimentari e accelerandone la scomparsa.
Dove le montagne siano basse e dunque manchino aree più alte ad appropriato innevamento e temperatura, il problema sorge prima. Sulle Alpi le associazioni vegetali possono migrare fino a 3500-4000 metri, ma non in Appennino, dove l’altezza media varia tra 1800 e 2200 metri.
Non voglio dire con questo che la fauna erbivora dell’Appennino si estinguerà, ma è destinata a cambiare parzialmente distribuzione. Forse qualche specie diminuirà di numero. Il problema si accresce quando le aree di rifugio non sono disponibili. O, se disponibili, non sono accessibili a causa di zone oggi fortemente antropizzate, che in passato non c’erano.
Le specie viventi esistevano infatti già qualche milione di anni fa e sono sopravvissute a centinaia di cambi climatici. Ma c’è un problema: oggi devono confrontarsi con l’impatto che l’uomo nel frattempo ha avuto sull’ambiente. I principali cambi climatici non sono mai durati meno di 200-300 anni, a volte anche migliaia di anni.
Quindi, pur se il cambio climatico attuale fosse interamente dovuto ai gas serra prodotti dall’uomo, e anche se oggi cessassimo di produrli, la quantità ormai presente nell’atmosfera sarà ancora sufficiente ad attivare il cambio climatico per circa un centinaio d’anni. Se già dopo qualche decennio di cambio climatico ci siamo accorti di tutti questi cambiamenti a livello ambientale, il problema è destinato ad aggravarsi. Ce ne siamo accorti, per ora, soprattutto sulle montagne che sono ambienti fortemente stagionali. Non possiamo fermare gli eventi naturali, ma certamente possiamo limitare l’inquinamento atmosferico causato dall’uomo.»

IL RITORNO DEI SELVATICI
In questi ultimi anni in Italia è cresciuta la polemica sulla convivenza con la cosiddetta fauna problematica, orsi e lupi in primis. Esiste una soluzione in grado di soddisfare tutti?
«Negli ultimi decenni, l’abbondanza di fauna selvatica, un po’ in tutta l’Europa e anche in Nord America, è cresciuta molto. Il fenomeno è stato eclatante, in quanto frutto di un maggiore rispetto dell’ambiente e dell’abbandono della montagna. Se i boschi tornano a ricolonizzare aree prima coltivate, la fauna associata alle foreste non può che esserne beneficiata. Se si ricrea una ricca comunità di erbivori selvatici dobbiamo aspettarci che anche i carnivori tornino a essere numerosi.
Questa è una parte della spiegazione. Un’altra parte è che l’uomo ha facilitato questa ricolonizzazione naturale degli spazi attraverso le reintroduzioni. Queste altro non sono la cattura di fauna dove è abbondante e la sua immissione in altre zone dove invece è scomparsa. E la sparizione, di solito, è a causa dell’uomo.
ZONE DI TRANSIZIONE
Per il capriolo, ad esempio, abbiamo costruito un ambiente ideale. Nessuna meraviglia che sia diventato così numeroso. Il capriolo è una specie probabilmente evolutasi in ambienti ecotonali. Sono zone di transizione tra gli spazi aperti e chiusi, nelle radure in mezzo alle foreste e al margine di queste. L’Italia era interamente coperta di boschi fino all’epoca romana. C’erano poche zone a steppa in Puglia, in Sardegna e qualche prateria d’altitudine sulle Alpi e in pochissime aree dell’Appennino. Tutto il resto era un manto forestale pressoché ininterrotto.
L’uomo ha disboscato pesantemente, togliendo l’habitat alla fauna di foresta. Ma siepi, boschetti e incolti sono eccellenti habitat ecotonali: una manna per caprioli e cinghiali.
L’ARRIVO DEI CINGHIALI…
Ora il bosco sta riconquistando il territorio e la fauna sta aumentando di numero. Ma nessuno le ha spiegato che un conto sono i parchi nazionali, un conto sono le colture agricole, gli orti e i giardini. Esiste una popolazione urbana di cinghiali a Roma, nei parchi di alcune ville.
Non si sa come ci siano arrivati. Non escludo che qualcuno abbia preso qualche cinghialetto (da piccoli sono bellissimi: sembrano salvadanai!), se li sia tenuti in casa. Poi, una volta cresciuti, ha deciso di liberarli. Comunque sia arrivato, il cinghiale è ora presente a Roma. Rovescia cassonetti, mangia immondizie ed è stato fotografato in mezzo a parcheggi e nei cortili.
… E DEI LUPI
Ovviamente, dopo l’arrivo della preda è arrivato anche il predatore. Già c’erano volpi urbane, ora anche qualche lupo è stato fototrappolato dentro Roma. Fin qui si parlava di conservazione, bisogna ora parlare di gestione. In alcune aree la presenza della fauna selvatica è incompatibile con quella dell’uomo. Quando la grande fauna selvatica si inurbi, o anche soltanto penetri nei campi coltivati, deve intervenire un’oculata e corretta gestione. Questo significa misure preventive del danno ed eventualmente controlli numerici.
La gestione, però, si va a confrontare con l’emotività umana. Per la persona media è molto difficile accettare la protezione di una specie in un’area e la sua uccisione o limitazione in un’altra.
LUPI IN CITTÀ
La presenza del lupo in ambiente urbano significa che prima o poi inizieranno a sparire i cagnolini nei parchi pubblici. Cominceranno a spaventarsi i bambini o le persone che se lo troveranno improvvisamente di fronte. Finora questo non è avvenuto, ma è molto ipotizzabile che possa succedere. Anche perché frequentando l’ambiente urbano la fauna prende confidenza. Fin quando è una volpe a perdere la paura dell’uomo, le conseguenze possono essere trascurabili. Se però comincia a essere un lupo, o peggio ancora un orso, allora i problemi ci sono eccome.
La gestione, però, si va a confrontare con l’emotività umana. Per la persona media è molto difficile accettare la protezione di una specie in un’area e la sua uccisione o limitazione in un’altra.
LA RIVALUTAZIONE DEL LUPO
Negli anni Sessanta venne rivalutata la figura del lupo, trasformandolo in una sorta di santo. Questo non solo in Italia, ma anche in Nord America e in Europa. Di lupi erano rimasti pochi, distrutti dall’uomo con il veleno, le trappole e con la caccia, e in modo indiretto con l’eliminazione delle sue prede selvatiche. Questo aveva fatto accentuare la predazione sul domestico e il lupo era stato ulteriormente perseguitato.
Negli anni Sessanta, anche grazie al divertente libro “Mai gridare al lupo” di Farley Mowat, la figura del lupo venne rivalutata. Secondo il libro, il lupo si nutriva soprattutto di piccoli roditori, presentandone un quadro falso. Falso quanto quello che prima lo equiparava a un demonio assetato di sangue.
Tutti e due questi approcci sono emotivi e fuorvianti. Il lupo non è né un santo né un demonio: è un grande carnivoro e come tale deve essere considerato. L’opinione pubblica va insomma educata e va fatta capire la differenza tra conservazione, quando una specie sia a rischio, e gestione, quando interferisca troppo con le attività antropiche.
LA DIFFUSIONE DELL’ORSO
Quello che è avvenuto con l’orso in Trentino sta diventando emblematico. Molti anni fa mi venne chiesto il parere dall’allora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica sulla eventuale reintroduzione di orsi in Trentino. Detti parere negativo.
Il parco dell’Adamello Brenta, area centrale di rilascio, può anche avere abbondanti risorse alimentari per l’orso. Ma chi spiega all’orso che deve stare solamente dentro i confini del parco? E, dopo che avrà colonizzato anche altre parti del Trentino, chi spiegherà all’orso che non deve diffondersi nei territori vicini?
È un grande carnivoro, ha un basso tasso di riproduzione ma comunque si moltiplica. Non è realistico pensare a una popolazione di orsi in un’area dove l’economia sia basata su turismo, sui frutteti, sugli alveari.
Se esce dal Trentino e va, per esempio, in Valtellina? I Valtellinesi, che non hanno scelto di avere l’orso, che diranno? E come si farà a sbarrare l’accesso agli orsi?
LA PROSPETTIVA GIUSTA
Mi dispiace dover dire che oggi i fatti mi stanno dando ragione, perché l’immissione di orsi venne fatta comunque. Ma i nodi stanno venendo al pettine e la loro soluzione è alquanto problematica.
Bisogna pensarci prima di generare il problema.
L’orso non è “cattivo”. Se a una femmina di Homo sapiens, a una mamma, viene minacciato il proprio bambino, la donna reagisce in modo aggressivo. Le femmine di cinghiale fanno la stessa cosa, la protezione della prole è un comportamento normale. Il problema è che con una femmina di Homo sapiens si può parlare, con un’orsa no. Più aumentano le femmine di orso con piccoli più aumenta il rischio di trovarsi in una situazione in cui si disturbino i cuccioli e l’orsa madre corra in loro aiuto.
Come nel caso del lupo, l’orso non è un orsacchiotto di peluche né un animale terrificante, è un… orso. Bisogna tenere la fauna nella prospettiva zoologica giusta, cercando di non farla estinguere ma, in alcune parti che l’uomo vuole riservare a sé stesso, la presenza di animali selvatici di grande mole può essere incompatibile.
PREVENZIONE E CONTROLLO
Bisogna pensarci prima di generare il problema. Quando il problema è stato creato, poi si rimedia molto male. Come risolvere il problema dell’espansione della popolazione di orsi? Con la caccia? La caccia è quanto di più inefficiente esista per la gestione della fauna, perché è attivata a livello emotivo, esattamente come l’animalismo. E quando si è emotivamente attivati, di solito si fanno errori.
La convivenza con ogni specie animale passa attraverso due azioni: prevenzione e controllo, in quest’ordine. Ma ogni soluzione deve realisticamente scaturire da una buona conoscenza della biologia della specie che s’intenda gestire. Per conoscere bisogna studiare… e per studiare occorrono fondi, che vanno ben impiegati.»

L’INCENDIO
Nel tuo libro “L’enigma delle pecore blu” parli della morte di un guardiaparco nel corso di una spedizione. Si corrono ancora grandi rischi nelle ricerche naturalistiche?
«La mia prima ricerca in Asia si svolse in Thailandia, nel 1986. Allora ero privo dell’esperienza necessaria per organizzare spedizioni scientifiche. Con due forestali thailandesi e due guardiaparco ero in un’area montuosa al confine con la Birmania, l’attuale Myanmar.
Era il periodo del caldo secco, quando nel nord della Thailandia bracconieri e coltivatori d’oppio danno fuoco a tratti di foresta. Lo scopo è sparare agli animali stanati dalle fiamme e poi creare campi d’oppio nelle aree deforestate, anche all’interno di aree protette. Non lo sapevo. La prima mattina contai qualcosa come quattordici incendi visibili dalla cresta delle montagne dove mi trovavo. Ero preoccupato più di quanto lo fossero i thailandesi che stavano con me. A un certo punto ci trovammo su una cresta rocciosa. Due goral, piccole capre grandi come camosci, si spostarono sotto i nostri occhi dietro a una pendice molto ripida.
LA TRAGEDIA
Guardando il fuoco che stava divampando oltre trecento metri più in basso e vedendo l’alta erba secca che copriva tutta la pendice, giudicai che convenisse tornare indietro. Poteva finire male se il vento avesse cambiato direzione. Non insistetti, perché era la mia prima esperienza in assoluto e perché, come ospite, non potevo certo imporre il mio volere. Dunque dissi che sarei tornato al campo e mi avviai con una guardia. Gli altri rimasero lì, e uno decise di filmare gli animali, scendendo dalla parte alta della pendice.
Un guardaparco, per impedire che i goral fuggissero, scese ancora più in basso fino a rasentare il dirupo, per far risalire i due goral. A quel punto cambiò il vento, che fino allora aveva tirato nella direzione opposta, e cominciò a spingere il fuoco su per la pendice. In un attimo le fiamme investirono il guardiaparco, che rotolò giù dal dirupo per un centinaio di metri e rimase su uno sperone roccioso, ormai morto, riverso sul dorso.
Bisogna partire con l’attrezzatura appropriata e sapersi imporre sugli altri, quando necessario, per evitare rischi inutili.
Il forestale che aveva causato questo problema uscì illeso, ma l’altro venne investito dal fumo denso che lo fece cadere all’indietro. Mentre si rialzava arrivarono le fiamme ustionandogli malamente le mani. In qualche modo riuscì a risalire la ripida pendice e ci raggiunse. Aveva le dita che sembravano salsicce arrosto. Eravamo con una guardia morta e un forestale ferito. Il tutto a più di un giorno di scomoda marcia dal villaggio più vicino e a due giorni di fuoristrada dal più prossimo ospedale.
I RISCHI DEL LAVORO SUL CAMPO
Condussi il collega ustionato al campo, gli lavai le mani con amuchina, poi spalmandogliele con crema contro le scottature solari: non avevo altro con me! Gliele fasciai con strisce di una camicia pulita, lo ficcai in tenda sotto shock e il mattino dopo lo mandai indietro con un guardiaparco, all’ospedale di Chiang Mai. Lo rividi a Bangkok quasi un mese dopo, ormai pressoché guarito ma con cicatrici biancastre ben visibili sulle dita e sul palmo delle mani.
Fu la mia prima esperienza e mi sentii molto in colpa verso il povero guardaparco morto, anche se di fatto la responsabilità non fu mia. Soprattutto mi resi conto che in questi contesti non siamo in Europa. Un conto è avere un incidente in Appennino o sulle Alpi, un altro è averlo in una foresta o su una montagna in una parte remota del globo. Bisogna partire con l’attrezzatura appropriata e sapersi imporre sugli altri, quando necessario, per evitare rischi inutili. È qualcosa che in seguito talvolta ho dovuto fare e non mi è successo più nulla di grave.»
PROSPETTIVE FUTURE
Quale sarà il futuro della conservazione e delle scienze del comportamento, secondo te?
«Non sorprendentemente c’è stata un’evoluzione, o forse un’involuzione, rispetto al passato. L’etologia era sulla cresta dell’onda negli anni Settanta e Ottanta, tanto è vero che nel 1973 venne assegnato il premio Nobel per la medicina a Konrad Lorenz, Karl von Frisch e Nikolaas Tinbergen per i loro studi d’etologia. Il premio pubblicizzò molto le discipline comportamentali, che così ebbero una notevole crescita.
Pian piano dall’etologia pura e semplice siamo passati all’ecologia comportamentale, cioè lo studio degli effetti delle determinanti ambientali sul comportamento. Ora, dall’ecologia comportamentale si sta passando alla biologia della conservazione. Questo perché in realtà l’etologia e l’ecologia comportamentale non fanno più notizia, sono discipline che venivano e vengono considerate di serie B, perché si articolano prevalentemente fuori dai laboratori, perché non salvano direttamente vite umane, perché spesso non vengono usati strumenti high tech, e perché – per così dire – non si fa uso di camici bianchi.
Il comportamento è l’aspetto più esterno del fenotipo, soggetto all’azione della selezione naturale alla pari della forma delle zampe, del colore degli occhi, del pelo e in generale della morfologia del corpo.
IL FUTURO DELL’ETOLOGIA
Tantissime volte mi sono sentito dire dai colleghi “beato te che sei abbronzato”. Il sole in effetti lascia il segno, ma se si è abbronzati non è perché siamo andati su una spiaggia a prendere il sole, bensì perché ci si muove in montagna o comunque all’aperto per raccogliere dati. Il sole lascia il segno, mentre pioggia, vento e basse temperature no o molto meno.
Nonostante fossero di etologia, cercai di pubblicare i miei primi lavori su riviste con un nome dove comparisse la parola zoology proprio per evitare che venisse negata la loro matrice zoologica.
LA NECESSITÀ DI STUDI SUL COMPORTAMENTO
Il comportamento è l’aspetto più esterno del fenotipo, soggetto all’azione della selezione naturale alla pari della forma delle zampe, del colore degli occhi, del pelo e in generale della morfologia del corpo. L’etologia è lo studio della morfologia del comportamento.
Per esempio, l’uomo ha sviluppato moltissimo la comunicazione verbale, ma esiste una comunicazione non verbale che è quella gestuale (e non solo), molto diffusa nelle scimmie, nei lupi e in generale negli animali superiori, che noi usiamo meno, ma esiste ancora. Tutto questo è oggetto di studio dell’etologia.
Forse la panna è stata già scremata dal recipiente di latte ma… dentro c’è ancora latte, che aspetta d’essere studiato: il fatto di veder declinare l’interesse verso discipline dalle quali finora è stata solo “tolta la panna” rattrista. Dobbiamo cercare di andare in profondità con ulteriori ricerche: la panna senza latte non esiste. Speriamo ci sia un cambio di tendenza…
TECNOLOGIA E LAVORO SUL CAMPO
(Gli sviluppi tecnologici hanno profondamente influenzato la ricerca scientifica in questi ultimi decenni. Lo scienziato mi confessa però di tenersi alla larga da alcune innovazioni, come i programmi di chat, preferendo un approccio più diretto. Stessa cosa per determinati utilizzi dell’informatica nella biologia. Incuriosito, gli chiedo allora qualche dettaglio in più.)
Cosa ne pensi dell’avvento della tecnologia negli studi naturalistici?
Spesso, quegli ordigni che si chiamano computer – e simili – ammazzano la ricerca scientifica. Vengono abusati e delegati a fare osservazioni che invece dovrebbe fare il ricercatore. Le fototrappole, i radiocollari satellitari sono strumenti preziosi per la ricerca scientifica. Ma non devono né possono eliminare il lavoro di campo. Perché è solamente sul campo, confrontandosi direttamente con le specie animali, che si evitano errori e si hanno intuizioni che altrimenti non si avrebbero. È però molto più facile, in termini sia di costi sia di apparenza, non lavorare sul campo ma utilizzare solo la tecnologia.
BIOLOGI DA POLTRONA
Questo sta producendo una intera generazione di quelli che gli inglesi definiscono easychair biologists, biologi da poltrona. Sono biologi che non sono mai andati sul campo, ma bravissimi a utilizzare il computer, a fare mappe colorate e raffinate, a produrre sintesi di dati pur in assenza di conoscenze naturalistiche dirette.
In passato mi è capitato di vedere la mappatura di un parco del Pakistan fatta attraverso immagini satellitari; era stata segnata la foresta in una zona che avevo visitato di persona e dove c’era soltanto un giovane rimboschimento di conifere. La persona esperta in GIS, geographic information system, che aveva realizzato la mappa da foto satellitari, alla quale feci presente l’incongruenza, mi rispose: «in effetti è possibile aver equivocato».
Troppo spesso si salta la raccolta o verifica dei dati di campo. Questo purtroppo è un marchiano errore che viene fatto anche a livello di organizzazioni internazionali di conservazione. Ad esempio la International Union for Conservation of Nature, la IUCN. Anche loro fanno bellissime mappe da cui viene dedotto se una specie sia a rischio di estinzione, usando dati che nel 99% cento dei casi sono tratti da campioni non rappresentativi.
MANCANZA DI FONDI
Inoltre non si trovano più finanziamenti per un serio lavoro di campo. Se un ricercatore fornisce una mappa geografica dalla quale appare se una specie sia abbondante o meno, pur basandosi su un campione non rappresentativo, e poi arriva un altro ricercatore che dichiara di voler verificare se questa mappa sia realistica, il primo ricercatore otterrà il finanziamento, il secondo no.
Dobbiamo ammettere di essere ancora tremendamente ignoranti del mondo naturale.
Se usciamo dall’Europa o dal Nord America siamo di un’ignoranza spaventosa per quanto riguarda i mammiferi, per non parlare degli insetti e altri gruppi zoologici: in alcuni casi arriviamo perfino a ignorare la semplice distribuzione delle specie. Ma chi va a contare, per esempio, gli organismi marini di profondità o quelli di dense foreste tropicali?
Dobbiamo ammettere di essere ancora tremendamente ignoranti del mondo naturale. Questo declino del lavoro in natura è una strada pericolosa intrapresa da fine anni ’80. Non fidiamoci soltanto dei cosiddetti mezzi remoti di raccolta dei dati, perché qualsiasi strumento è utile, ma solo quando c’è dietro il cervello dell’uomo che lo guida e quando viene usato appropriatamente. E comunque nulla può sostituire l’osservazione diretta in natura.
Un sentito ringraziamento va alla Proeco e all’Orto Botanico dell’Università di Siena per l’ospitalità.