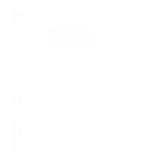L’arrivo dello sciacallo dorato (Canis aureus) in Italia è una delle vicende più sorprendenti della recente storia naturale del Paese. Originario del sud-est europeo e diffuso soprattutto nei Balcani, questo canide ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia a partire dagli anni Ottanta. Inizialmente segnalato solo con sporadici avvistamenti, è oggi una presenza stabile e in forte espansione.
Negli ultimi quindici anni il processo di colonizzazione ha subito un’accelerazione tale da rendere il Friuli Venezia Giulia un’area di insediamento stabile della specie in Italia, con decine di nuclei familiari. Le aree di maggiore densità si trovano nel Carso triestino e goriziano, nelle zone umide di pianura e lungo i margini delle aree forestali pedemontane.
«Negli anni Ottanta avevamo soltanto qualche avvistamento isolato», ricorda Nicola Bressi, zoologo e direttore del Museo di Storia Naturale di Trieste. «Poi, fino al 2010, la crescita è stata lenta. Ma negli ultimi quindici anni l’aumento è stato rapidissimo: oggi il Friuli Venezia Giulia è l’area di colonizzazione più importante per lo sciacallo dorato in Italia».
Ecologia di un carnivoro opportunista
Lo sciacallo dorato pesa tra i 10 e i 15 kg, una taglia intermedia tra la volpe e il lupo. La sua dieta è flessibile: piccoli mammiferi, uccelli, anfibi, insetti, frutta, carogne e rifiuti. Questa flessibilità alimentare lo rende un predatore generalista e ne spiega l’espansione in ambienti molto diversi, dalle zone agricole ai margini urbani.
Dal punto di vista etologico, lo sciacallo dorato presenta una struttura sociale basata su coppie riproduttive solitamente monogame e stabili, che difendono il territorio con marcature odorose e vocalizzazioni. A queste unità possono talvolta unirsi i giovani delle cucciolate precedenti, che collaborano all’allevamento dei nuovi nati: un comportamento di cooperative breeding documentato anche in altri canidi sociali. L’estensione del territorio è fortemente variabile in funzione della densità di prede e delle caratteristiche ambientali: può ridursi a pochi chilometri quadrati in zone agricole ricche di risorse, oppure superare le decine di chilometri quadrati in ambienti marginali o meno produttivi. Lo sciacallo è una specie antropofila, può vivere ai margini di insediamenti umani, in cerca di rifiuti con cui cibarsi. Ha un’elevata socialità e un ampio repertorio vocale.

Maschio subadulto di sciacallo dorato. Torrente Torre (Udine), settembre 2024.
Rischi e percezioni
Per l’essere umano il rischio diretto è molto basso, ma non assente: gli episodi di aggressione registrati nel suo areale riguardano quasi sempre animali affetti da rabbia (osservati in India, Bangladesh, Sri Lanka, Israele) oppure individui eccessivamente abituati alla presenza e al cibo fornito dall’essere umano. Ben più rilevante è invece il potenziale conflitto con allevatori e cacciatori.
Le predazioni sul bestiame domestico sono in genere limitate. «Parliamo di qualche gallina, un agnello o pecore molto anziane», osserva Bressi. «Con un semplice recinto o un cane da pastore il problema si riduce drasticamente». Molto più acceso è il conflitto con il mondo venatorio. «La percezione pubblica dello sciacallo dorato è polarizzata e in peggioramento, non solo in Italia», spiega Stefano Pecorella, coordinatore di un gruppo di ricerca attivo dal 2021. «Siamo uno dei pochi Paesi europei che non applica un controllo letale. Il contrasto maggiore è con i cacciatori, perché lo sciacallo predando i piccoli di capriolo viene percepito come un avversario diretto».
La letteratura scientifica conferma che in Europa lo sciacallo preda soprattutto micromammiferi ma può catturare anche cuccioli di ungulati, in particolare i neonati di capriolo. Ma l’impatto complessivo sulle popolazioni di questo cervide resta incerto. «Non sappiamo quanto incida realmente sulla densità dei caprioli», continua Pecorella. «Per capirlo servono dati complessi: produttività e qualità dell’habitat, competizione con cervi e altri ungulati, cambiamenti del paesaggio agricolo e forestale. Solo mettendo insieme questi fattori in modelli matematici è possibile stimare l’effettivo impatto predatorio su una specie».
In Friuli Venezia Giulia si sono registrati diversi episodi di bracconaggio e avvelenamenti. «Abbiamo avuto casi documentati di sciacalli uccisi a fucilate o con esche tossiche», denuncia Bressi. «Il veleno però non colpisce solo gli sciacalli: uccide cani domestici e altre specie selvatiche. È un crimine contro la natura». Nel 2024 una necroscopia su un esemplare rinvenuto morto ha confermato l’avvelenamento, e altri casi sono stati registrati nel Carso goriziano. Secondo i ricercatori, il fenomeno potrebbe essere sottostimato per la difficoltà di rinvenire i corpi.

Giovane femmina di sciacallo dorato, avvelenata. Torrente Torre, (Udine), aprile 2022.
Sciacallo dorato, prevenzione e soluzioni
Dal punto di vista normativo lo sciacallo dorato è inserito nell’Allegato V della Direttiva Habitat e nella Convenzione di Berna. Questo significa che qualsiasi intervento di controllo nei paesi UE può essere autorizzato purché non comprometta lo “stato di conservazione favorevole” della specie. Inoltre, in Italia, è inserito nella lista delle specie particolarmente protette della Legge Nazionale 157 del 1992. In pratica, un quadro legislativo molto rigido che rende complessa qualsiasi ipotesi di abbattimento selettivo. Per ridurre i conflitti, la Regione Friuli Venezia Giulia ha scelto di equipararlo ai “grandi carnivori” (lupo, orso e lince).
Questo passaggio non è solo simbolico, ma ha conseguenze pratiche. Sono stati predisposti indennizzi economici per gli allevatori colpiti da predazioni. Secondo i dati regionali, nel triennio 2021-2023 le richieste di indennizzo per predazioni attribuite a sciacallo dorato sono state alcune decine l’anno, per un importo complessivo di circa 20-30 mila euro annui, molto inferiore rispetto a quanto speso per danni da lupo. Oltre ai rimborsi, inoltre, la Regione eroga contributi per l’acquisto di recinzioni elettrificate, reti mobili, ricoveri notturni e cani da guardiania. Proprio come per il lupo, è stato introdotto un canale diretto per la segnalazione dei danni e la richiesta di indennizzo.

Femmina adulta di sciacallo dorato, torrente Torre (Udine), dicembre 2021.
«L’inclusione dello sciacallo tra i grandi carnivori ha consentito di estendere subito agli allevatori gli strumenti già rodati per il lupo», commenta Bressi. «In questo modo il danno economico viene ammortizzato e si riduce la tentazione di ricorrere a soluzioni illegali come bracconaggio o veleni». Un dato interessante riguarda l’efficacia delle misure preventive: i progetti di monitoraggio condotti con il supporto dell’Università di Udine hanno evidenziato che gli allevatori che hanno adottato sistemi di protezione hanno subito il 38% in meno di predazioni rispetto a chi non ha introdotto alcuna misura.
Ma restano interrogativi aperti. «Quando si dice che il problema dello sciacallo è più percepito che reale, io invito alla cautela», avverte Pecorella. «Studi recenti pongono interrogativi e preoccupazioni sulla sua rapida espansione, che presenta analogie con quella di una specie invasiva, anche se quella dello sciacallo è un’espansione naturale favorita indirettamente dall’uomo. Dal punto di vista sanitario, come ogni specie selvatica può veicolare malattie e parassiti trasmissibili ad animali domestici o all’uomo. Dal punto di vista ecologico, parliamo di una specie che fino a qualche decennio fa era confinata nel sud-est europeo, e che ora – per cause legate all’uomo – si sta espandendo in ecosistemi dove non era mai stata presente, con effetti non chiari sulle specie native».
Il futuro dello sciacallo dorato in Italia
La dinamica di popolazione suggerisce che in Friuli Venezia Giulia lo sciacallo dorato stia raggiungendo la massima densità sostenibile. L’espansione proseguirà probabilmente verso altre regioni italiane, seguendo corridoi ecologici già utilizzati dal lupo. «Credo che, in qualche decennio, potremo vederlo aggirarsi di notte in città come Udine, un po’ come già succede con le volpi a Londra», ipotizza Bressi.
La sfida sarà gestire questa nuova presenza con strumenti scientifici e strategie di convivenza. Per Pecorella il nodo centrale è «capire che ruolo avrà nei nostri ecosistemi, quale impatto reale avrà sulle sue specie preda, sui carnivori nativi, sulla biodiversità e sulla salute pubblica».
La storia dello sciacallo dorato in Friuli Venezia Giulia non è più quella di un arrivo inatteso: è la storia di un insediamento stabile e di una convivenza da costruire. Una convivenza che richiede monitoraggi rigorosi, gestione adattativa e comunicazione chiara con le comunità locali. Perché la presenza di questo predatore, lungi dall’essere un’anomalia, è ormai parte integrante della nuova fauna italiana.

Maschio adulto di sciacallo dorato. Golene del torrente Torre (Udine), giugno 2024.