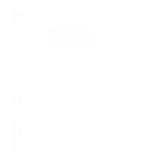Arrivata in Italia nel 2013-2014 dalla Francia, il calabrone asiatico (Vespa velutina) è oggi una delle specie aliene invasive più problematiche per l’apicoltura e gli ecosistemi. Elencata tra le specie di “rilevanza unionale” dall’UE, non può essere trasportata, allevata o rilasciata, ma contenerne la diffusione resta una sfida enorme.
«L’arrivo risale al 2013-2014, quando la specie si è insediata in Liguria. All’inizio si sperava ancora nell’eradicazione, ma in breve tempo è stato chiaro che era impossibile», spiega Laura Bortolotti, ricercatrice del CREA. «In un territorio aperto e con continui scambi transfrontalieri era irrealistico pensare di eliminarla. L’unico caso riuscito di eradicazione è avvenuto in un’isola, a Maiorca».
Un predatore di api e impollinatori
La Vespa velutina è un vorace predatore di api domestiche (Apis mellifera), ma anche di api selvatiche e altri insetti impollinatori. Il suo impatto sugli alveari è devastante: quando le colonie sono deboli o già compromesse da malattie o pesticidi, possono collassare in breve tempo. «Colonie forti e popolose si difendono meglio: Vespa velutina non riesce a distruggere un alveare sano», sottolinea Bortolotti. «Il problema nasce quando l’alveare è già debilitato». Non sorprende che i beekeeper la indichino tra le principali cause del declino delle api, al pari dei pesticidi. Gli effetti si estendono anche alla biodiversità: alterando le comunità di insetti impollinatori, Vespa velutina innesca squilibri ecologici che si ripercuotono sulle catene alimentari.
Nei primi anni dal suo arrivo, ISPRA e l’Università di Torino hanno elaborato linee guida per il monitoraggio e la distruzione dei nidi. «La neutralizzazione dei nidi è ancora oggi la tecnica ufficialmente più utilizzata: con lunghe aste telescopiche si introduce una polvere piretroide all’interno del nido», racconta la ricercatrice. «Il problema è che i nidi si trovano spesso molto in alto, fino a venti metri sugli alberi, e non sempre si riesce a rimuoverli».
La strategia funziona solo quando i nidi sono pochi. In aree come Liguria e Toscana, dove ormai se ne contano centinaia, diventa insostenibile. Per questo sono stati sperimentati anche i cosiddetti “metodi troiani”, con vespe trattate con microdosi di insetticida che diffondono la sostanza nel nido. «Sono metodi molto efficaci, già usati contro formiche e scarafaggi, ma non ancora autorizzati per Vespa velutina», precisa Bortolotti.
LEGGI ANCHE: Lo sciacallo dorato in Italia, un’espansione silenziosa
Progetti e innovazioni
Grazie al progetto europeo LIFE STOPVESPA, in Italia sono state create squadre specializzate per la localizzazione e distruzione dei nidi. Sono state introdotte tecniche innovative come il radar armonico e la radiotelemetria: piccoli tag applicati alle vespe permettono di seguirle fino al nido, individuando colonie altrimenti invisibili.
«Se si neutralizzano subito i primi nidi, si può almeno rallentare la diffusione», spiega la ricercatrice. «Ma al momento non c’è una soluzione definitiva: la neutralizzazione resta necessaria ma non sufficiente, e i metodi troiani non sono ancora legali». Il bilancio non è trascurabile: durante il progetto LIFE STOPVESPA sono stati individuati e distrutti oltre 2200 nidi, contribuendo a contenere l’avanzata della specie.
Adattamento e convivenza
Secondo Bortolotti, l’eradicazione non è più un’opzione. «Possiamo al massimo pensare a contenere le popolazioni e a mantenerle sotto una certa soglia. E parallelamente le api e gli apicoltori dovranno adattarsi: come è successo con il parassita Varroa destructor, dovranno imparare a convivere con un nuovo nemico».
Gli apicoltori hanno già messo in campo strumenti di difesa immediata, come griglie protettive, arpe elettriche o racchette che fulminano le vespe davanti agli alveari. Sono misure tampone, che non riducono la popolazione del calabrone asiatico ma aiutano a salvare gli alveari.
Intanto, le segnalazioni continuano a crescere: dal 2014 a oggi sono oltre 10.000, sempre più frequenti negli ultimi cinque anni. «Credo che dovremo imparare a convivere sia con Vespa velutina che con Vespa orientalis», conclude Bortolotti. «Sono specie predatrici, generaliste, favorite anche dal cambiamento climatico. Fermarle è praticamente impossibile. Possiamo contenerle, ridurne l’impatto e adattare le pratiche apistiche».