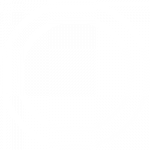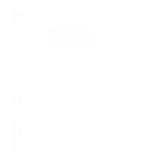L’odore è quello della terra bagnata mischiata a spazzatura. Il Vesuvio fa da cornice a tredici capannoni abbandonati nell’hinterland di Pompei, che traboccano di seimila tonnellate di rifiuti speciali, tra vestiti usati, accessori per l’abbigliamento, pezzami da lavorazione e scarti tessili.
Sottoposti a sequestro dal 2018, i capannoni sono solo la punta dell’iceberg di una filiera illegale. Da questo punto, infatti, sono partite le attività investigative condotte dai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.
A luglio del 2020, l’operazione Hercules ha accertato un traffico illecito di rifiuti nel territorio di Napoli, Melito di Napoli, Boscotrecase, Terzigno, Pompei e Castellammare di Stabia. Dodicimila tonnellate di rifiuti accatastati in capannoni sparsi nelle campagne del territorio. Alla luce del sole. Tra case, autofficine e campi di cicoria.
Vestiti usati e criminalità organizzata
Uno smaltimento illegale, effettuato senza rispettare le procedure previste dalla normativa ambientale. Dal quadro indiziario elaborato dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata emerge la sussistenza di una sistematica raccolta e movimentazione di rifiuti. Questi provengono da aziende di tessuti e abbigliamento operanti nel settore del trattamento e smaltimento.
«La dinamica è semplice: le oltre dodicimila tonnellate di rifiuti speciali, vengono stoccate illecitamente in enormi capannoni presi in affitto da ignari proprietari. Questo grazie al coinvolgimento di alcuni autotrasportatori. Ai proprietari il sodalizio talvolta non porta neppure il canone di locazione – racconta Giuliano Ciotta, Capitano della Guardia di Finanza di Torre Annunziata –. Una volta completamente riempiti, i capannoni vengono abbandonati. Un modus operandi che si ripete ogni volta che la criminalità organizzata mette le mani nel settore degli abiti di seconda mano».
Secondo la fondazione antimafia Caponnetto, ogni anno in Italia si raccolgono 110.000 tonnellate di vestiti usati. Una media di 1,8 chili per abitante. Il Capitano Giuliano Ciotta conferma un punto essenziale: gli indumenti usati fanno parte di un settore estremamente redditizio. Settore in grado, a volte, di portare maggiori profitti del traffico di droga. La “droga pulita”, così viene definito questo business in alcune intercettazioni ambientali.
Ogni anno in Italia si raccolgono 110.000 tonnellate di vestiti usati, una media di 1,8 chili per abitante.

L’operazione Hercules ha accertato un traffico illecito di rifiuti che conta 12.000 tonnellate di rifiuti accatastati nelle campagne del territorio campano. Tredici capannoni sono stati sequestrati proprio sotto al Vesuvio, con circa seimila tonnellate di rifiuti speciali tra indumenti usati, accessori per l’abbigliamento, pezzami da lavorazione e scarti tessili. Pompei (NA), Italia. Settembre 2020.
I LIMITI DELLA FILIERA
Prima del loro stoccaggio illegale la raccolta dei vestiti usati avviene nelle città italiane. «Cooperative sociali a sfondo benefico gestiscono la raccolta – racconta Stefano Vignaroli, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Ecomafie dal 2018 – attraverso cassonetti stradali che in più di un caso riportano il logo della Caritas. Gli indumenti usati raramente vanno ai poveri. Quasi sempre vengono venduti e i proventi non sempre sono usati a fini benefici. In Italia esistono due poli principali della filiera dei vestiti usati. Uno è Prato, l’altro è la Campania, terra di origine delle famiglie camorristiche che tengono sotto scacco il settore».
Una faccenda alquanto risaputa. Nel 2012, di fronte ai parlamentari della Commissione Antimafia, il magistrato Ettore Squillace Greco affermava «I campani sanno bene che ad Ercolano non si vendono stracci se non si è legati al clan Birra-Iacomino».
Gli indumenti usati raramente vanno ai poveri: quasi sempre vengono venduti e i proventi non sempre sono usati a fini benefici.
Una fonte anonima dichiara di aver lavorato come operatore per una cooperativa sociale attiva nella raccolta di indumenti usati. La voce anonima denuncia il complesso e ambiguo mondo delle cooperative. «Lavorare all’interno di una di queste cooperative significa avere ben chiara la spartizione del territorio» chiarisce la fonte. «Non è difficile ottenere tutte le autorizzazioni richieste per effettuare la raccolta. Se una cooperativa è ben inserita nella politica del territorio, gli uffici tecnici tendono ad essere più comprensivi».
Iscriviti alla Newsletter di RADAR
Potrai partecipare alla crescita del nostro magazine e riceverai contenuti extra
Fattore di conversione
Dopo la raccolta e il trasporto nelle R13, per arrivare alla “conversione” da rifiuto – la legge italiana valuta così l’abito usato – a bene riutilizzabile, intervengono delle aziende private che si occupano di compravendita di vestiti usati. «Nel caso della cooperativa per cui lavoravo, gli abiti raccolti finivano in un’azienda di Prato. Questa poi mandava i suoi camion a ritirarli, pagandoci al chilo. Poi ci è stata indicata un’altra impresa, questa volta in Campania» continua la fonte.
«Noi facevamo parte di una rete, che parlava direttamente con i politici locali anche ad alto livello. Senza di loro, noi non avremmo avuto il permesso di raccogliere. Nel nostro caso, bastava che l’ente benefico a cui eravamo legati indicasse al Comune la cooperativa e ci affidavano automaticamente il servizio. Fu così per molto tempo. L’ente benefico a cui eravamo legati era la Caritas, nel nostro caso. Poi è cominciato il sistema delle gare, ma non è cambiato molto. Chi le scriveva faceva in modo che vincessimo».
La fonte anonima fa poi riferimento ad un grande quantitativo di sommerso, di denaro non dichiarato. «Ora stiamo più attenti su questo aspetto, ma circa metà del denaro continua a girare a nero grazie alla sottofatturazione. È denaro contante, liquido. Spesso sono proprio le aziende private che portano i borsoni per pagare gli abiti.
Non è facile uscire dal sistema. Tutti nel nostro settore sanno che le società che si comprano vestiti molto spesso sono legate alla Camorra. Ci veniva fatta pressione. Ci veniva detto che dovevamo avere rapporti con la camorra per evitare ritorsioni commerciali o violente».
Il viaggio dei vestiti usati in Africa Orientale
Le aziende private che hanno acquistato rivendono all’estero la stragrande maggioranza di questi indumenti, dopo la raccolta da parte delle cooperative sociali.
La principale destinazione dell’export italiano è Tunisi. E da Tunisi, poi, si apre l’ingresso per l’Africa Orientale. Questa è terra di vendita e di scontro di più potenze internazionali, per un giro d’affari globale che vale 4 miliardi di euro. Un’economia così grande da alimentare il PIL di interi Paesi africani.
È una filiera che dà lavoro a milioni di persone, un lavoro per la maggior parte informale, senza orari, senza tutele.
In Tanzania, i vestiti di seconda mano si chiamano mitumba. E fanno parte di un settore che lega il Vesuvio al Kilimanjaro e disegna la geografia del settore più globalizzato per eccellenza. Dal trasporto allo stoccaggio, i mitumba girano il mondo più di tutte le altre merci. Il commercio di mitumba è cresciuto esponenzialmente negli ultimi dieci anni.
Un mercato immenso
Lo UN Comtrade, il database delle statistiche sul commercio delle materie prime delle Nazioni Unite, fornisce numeri impressionanti. Le esportazioni mondiali hanno raggiunto i 4,8 miliardi di dollari. Solo l’Africa orientale ha importato vestiti e scarpe usati per un valore di 151 milioni di dollari.
Secondo il Ministero del commercio della Tanzania, il settore dei mitumba colma il vuoto che lascia quello del tessile locale. Questo non è infatti ancora in grado di soddisfare la domanda di vestiti. È una filiera che dà lavoro a milioni di persone, un lavoro per la maggior parte informale, senza orari, senza tutele. La pandemia da Covid-19 non ha modificato questa catena di montaggio. In tutta l’Africa, fino al 30% del lavoro informale (volgarmente detto “lavoro nero”) ruota intorno al commercio di vestiti usati.
Video di Martina Di Pirro e Maged Srour. Illustrazione iniziale di Francesca Ferrara.
Un costo ambientale insostenibile
Secondo un rapporto dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale USAid, nell’Africa orientale il mercato dell’usato raggiunge i 230 milioni di dollari. E si tratta solo di profitti, per un totale di 355.000 posti di lavoro. Un valore così alto da indurre associazioni di categoria statunitensi, come la Secondary Materials and Recycled Textiles (SMART), ad agire per via legale. Questo avvenne non appena alcuni paesi africani – Tanzania, Uganda, Rwanda – decisero di imporre un veto all’importazione di vestiti usati. Fu un vano tentativo di favorire le economie locali.
Le pressioni della SMART si traducevano in minacce di sanzioni commerciali. Ad esempio l’uscita forzata dall’African Growth and Opportunity Act, un accordo commerciale preferenziale tra Stati Uniti e alcuni paesi dell’Africa subsahariana. Questo accordo consente dazi ridotti o nulli su circa 6.500 tipi di merci.
«I dazi non violavano i termini dell’AGOA – racconta Paul Ryberg, avvocato di base a Washington, esperto di commercio internazionale e presidente della African Coalition of Trade (ACT) –. Nella maggior parte dei casi, la produzione degli indumenti era avvenuta al di fuori degli Stati Uniti. Quindi non potevano qualificarsi come export statunitense. Almeno una parte della lavorazione dovrebbe aver avuto luogo negli Stati Uniti. In questo modo si ottiene il riconoscimento di export targato USA, cosa che non è accaduta».
Un’industria che genera lo stesso PIL della Francia
Gli interessi difesi rispecchiano la grandezza del mercato. In generale, l’industria della moda è capace di muovere da sola più di 2,5 migliaia di miliardi di dollari in tutto il mondo. Una cifra pari al PIL della Francia.

Apertura delle balle di mitumba e selezione dei vestiti da tenere. Mercato di Manzese, Dar es Salaam, Tanzania. Agosto 2020.
Le Nazioni Unite ne raccontano l’impatto ambientale: l’85% dei vestiti prodotti finisce in discarica e solo l’1% va alla fase di riciclo, senza contare i circa 80 miliardi di abiti scartati ogni anno per difetti di fabbricazione. Si stima che con circa 600 chili di indumenti usati ci sarebbe una riduzione di 2250 chili di emissioni di CO2, e si risparmierebbero circa 3,6 miliardi litri di acqua. Chiaramente, come in ogni settore del marketing, è la domanda che tira l’offerta. Insomma, un costo ambientale che non è più sostenibile.
L’inchiesta Di Mano in Mano – il viaggio di una abito di seconda mano dall’Occidente all’Africa di Martina Di Pirro, Maged Srour e Francesca Ferrara è risultata vincitrice del Premio per il giornalismo investigativo e sociale della ONG Mani Tese e l’AICS. L’intera inchiesta è disponibile al sito Manitese.it/di-mano-in-mano