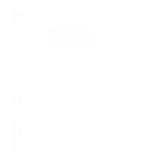Qui, lungo questa soglia oceanica che separa l’Oceano Atlantico da quello Artico, avvengono importanti scambi nutritivi, chimici e di energia in grado di influenzare la vita negli oceani – da cui dipende anche parecchia vita fuori dagli oceani stessi, incluse le risorse ittiche per noi.
I ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS, Trieste), dell’Istituto di Scienze Polari e Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino del CNR, e alcuni tecnici dell’ENEA avevano pianificato la campagna lungo il 75esimo parallelo. Lungo questo transetto disegnato, facilmente riconoscibile su un mappamondo, succede qualcosa di importante: le correnti calde provenienti dalle regioni tropicali si raffreddano al punto da inabissarsi sotto il loro stesso peso, raggiungere il fondale marino, e da lì riprendere il cammino verso sud. Nel giro di qualche secolo queste masse d’acqua, di nuovo calde, torneranno a galla per riprendere il ciclo e il flusso verso le regioni polari. È un processo caratteristico dei fluidi, che ridistribuiscono il calore in tutto lo spazio che occupano. Qui, lungo questa autentica soglia oceanica che separa l’Oceano Atlantico da quello Artico, avvengono importanti scambi trofici (scambi nutritivi), chimici e di energia in grado di influenzare la vita negli oceani – da cui dipende anche parecchia vita fuori dagli oceani stessi, incluse le risorse ittiche per noi. La risposta delle comunità biologiche di pesci e organismi planctonici al cambiamento climatico non è qualcosa che riguarda solo le balene, o alcune comunità Inuit che abitano le coste settentrionali canadesi, ma ciò che succede lungo questa soglia oceanica ha un impatto anche su di noi. E come è importante monitorare (che significa seguire nel tempo, raccogliere dati e informazioni) l’aria sulle nostre città, lo stato di salute dei nostri laghi e fiumi, la produttività dei nostri suoli, è fondamentale fare lo stesso anche lontano dalle comunità umane, in regioni nevralgiche per il futuro dell’umanità.