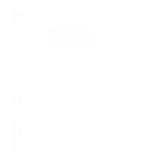Quando, nel 2022, alla Fornace Fonti di Rovigo arrivò una richiesta di preventivo per dei supporti in laterizio, Luca Fonti rimase perplesso. «Ho pensato fosse una richiesta anomala e l’ho evasa senza grande aspettativa», racconta nell’ufficio in mattoni rossi che condivide con il cugino Stefano. Entrambi gestiscono l’azienda di famiglia costruita dal trisnonno Giuseppe Fonti su un paleo-alveo del fiume Po nel lontano 1873. Solo alla stesura del contratto, Luca Fonti si rese conto che dietro quella strana richiesta ci fosse un progetto ambizioso: il restauro del mare. «Era qualcosa di affascinante, che ci mancava», racconta. Non aveva infatti mai pensato che i suoi laterizi potessero essere posati sul fondale per recuperare ecosistemi marini.
Il mare in questione è l’Adriatico, che nei secoli ha permesso alle comunità costiere di prosperare grazie alle sue generose risorse. Tra queste, i banchi naturali di ostrica piatta, Ostrea edulis, sono sempre stati tra gli habitat più pregiati. Un tempo abbondanti, oggi questi reef sono funzionalmente estinti.

Luca Fonti, proprietario dell’Antica Fornace Fonti, mostra una tavella in laterizio prodotta per il progetto di ripristino dei banchi a ostriche e la stessa rifinita con la stesa di bio-intonaco, Rovigo, 17 settembre 2025.
LETTI DI MADREPERLA PER LE OSTRICHE
«Lo sfruttamento eccessivo della pesca ad alto impatto sul fondale, come ad esempio con l’attrezzo chiamato ostreghero [una sorta di imbuto con cui si rastrella il fondale sabbioso], eventi di anossie e malattie hanno ridotto la dimensione della popolazione facendoci perdere gli habitat strutturali, non la specie», spiega Saša Raicevich, primo ricercatore dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e co-coordinatore del progetto di ripristino. Il degrado è così profondo che a livello europeo i banchi di ostriche native sono tra gli habitat marini più minacciati, definiti “in pericolo” nella Lista Rossa Europea. «Quindi quello che abbiamo perso è qualcosa di più della somma delle parti: abbiamo perso un ecosistema, non semplicemente la specie ingegnere, come in alcuni casi viene chiamata l’ostrica piatta», aggiunge Raicevich.
Questo bivalve, che nei secoli ha abbondato sulle tavole di papi, nobili e imperatori, ha infatti la peculiare capacità di aggregarsi e cementarsi su substrati duri, come ad esempio gusci di conchiglie, rocce e detriti legnosi, formando strutture tridimensionali complesse, appunto le barriere o reef di ostriche. Questi habitat favoriscono la biodiversità, migliorano la qualità delle acque e fungono da protezioni naturali contro l’erosione costiera. Nel 2021, l’Italia ha avviato un intervento di ripristino su larga scala di banchi naturali di ostriche in Adriatico all’interno del Progetto MER (Marine Ecosystem Restoration), promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e finanziato dal PNRR. Con un finanziamento di 400 mln di euro, il Progetto MER contribuisce all’attuazione della Strategia Europea per la Biodiversità, che ha fissato per il 2030 il traguardo di proteggere il 30% dei mari dell’Unione Europea. Non soltanto il ripristino dei banchi naturali di ostriche piatte, quindi, ma 37 interventi su larga scala per il monitoraggio, il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini in Italia.
IL MARE DEL PASSATO
I siti scelti per ricostruire le ostricare naturali sono sette e si snodano tra le 2 e le 5 miglia marine in Adriatico, di fronte alle coste italiane dal Friuli-Venezia Giulia all’Abruzzo.

Mappa dei sette siti scelti per ricostruire le ostricare naturali. Credito: ISPRA
«Sono stati selezionati perché [in questi punti] in passato era già nota la presenza delle ostriche», racconta Raicevich che, assieme al team di ricerca e in collaborazione con la storica Maria Lucia De Nicolò, ha analizzato diverse fonti storiche per poter determinare i luoghi più adatti al progetto di ripristino ecologico. Secondo De Nicolò, esperta di storia della pesca nel Mediterraneo in età moderna e oggi Direttrice del Museo della Marineria W. Patrignani di Pesaro, «la navigazione a braccetto tra storici e biologi è fondamentale per progettare la ricostruzione degli ecosistemi».
Infatti, mentre la raccolta di dati scientifici sulle specie e sugli aspetti fisico-climatici è fondamentalmente recente – si parla di qualche decennio, dalla seconda metà del ‘900 – l’impatto delle attività umane sugli ecosistemi è dell’ordine dei secoli, se non di millenni. Il ruolo dello storico è allora quello di interrogare annali, relazioni diplomatiche, testi di legge, trattati scientifici, dipinti, cronache locali e diari di viaggio per ricostruire le dinamiche di sfruttamento, le geografie degli habitat e la biodiversità del passato.

Maria Lucia De Nicolò presso il Museo della Marineria W. Patrignani, Pesaro, 10 ottobre 2025. De Nicolò ha contribuito all’individuazione dei siti più idonei al ripristino dei banchi a ostriche in Adriatico, in base alle informazioni storiche trovate sulla presenza di banchi naturali del passato.
De Nicolò racconta che la presenza di ampi banchi di ostriche nell’Adriatico è documentata fin dall’epoca romana. Ma sono le descrizioni settecentesche dell’oceanografo e naturalista Luigi Ferdinando Marsili a dare testimonianza di uno dei più estesi reef di ostriche in Adriatico. Nelle relazioni sulle sue esplorazioni sottomarine, Marsili parla di banchi paralleli alla costa tra Romagna e Marche dove le ostriche erano così abbondanti da essere «quasi collocate una sopra l’altra a guisa delle pietre, che formano un muro» per centinaia di chilometri.
Per favorire la rinascita di queste architetture viventi, nel maggio 2025 ISPRA, in collaborazione con aziende di settore, ha iniziato la posa di gabbie in ferro dolce tra i 14 e i 29 metri di profondità, contenenti tre diversi tipi di materiali per offrire quel substrato iniziale su cui le larve di Ostrea edulis possano attaccarsi e crescere. Nella scelta delle matrici – gusci di bivalvi, pietre calcaree, tavelle ricoperte di bio-intonaco – ha influito il “gusto” delle larve stesse, che preferiscono colonizzare materiali della stessa specie o famiglia, per loro garanzia di un ambiente adatto allo sviluppo.

Gli operatori della società benefit Circular Venice srl costruiscono un gabbione in ferro dolce per contenere i substrati (bioclasti, tavelle con biointonaco) utilizzati per la rigenerazione dei banchi a ostriche, Porto Viro (RO), 17 settembre 2025.

Un operatore di Circular Venice srl sposta un gabbione in ferro dolce pronto per essere riempito di substrato, nel cantiere di lavoro a Porto Viro (RO), 17 settembre 2025.

Gli operatori di Circular Venice srl riempiono i sacchi in cotone biodegradabile con i bioclasti, nel cantiere di lavoro a Porto Viro (RO), 17 settembre 2025.

I gusci di bivalvi, detti bioclasti, che vengono utilizzati come substrato, provengono dagli scarti di produzione e lavorazione di vongole, cozze e ostriche concave nella laguna di Comacchio e sono stoccati da Circular Venice srl nel cantiere di lavoro a Porto Viro (RO), 17 settembre 2025.
Il bio-intonaco utilizzato è un brevetto olandese, una pasta bianca costituita da polvere di gusci di ostriche e leganti naturali, che si era dimostrata molto efficace nella realizzazione di progetti di ripristino già sviluppati in Europa. Steso a mano dai dipendenti della Fornace Fonti su 14000 tavelle in argilla vergine del Po, oggi si trova sul fondo del mare Adriatico per offrire una nuova casa all’ostrica piatta. Il substrato a base di gusci di bivalvi, detti bioclasti, proviene invece dagli scarti di produzione e lavorazione di vongole, cozze e ostriche concave delle lagune del Delta del Po. Un’opportunità importante per chiudere le filiere ittiche e della molluschicoltura in un’ottica di economia circolare, sottolinea Saša Raicevich.

Alcuni operai dell’Antica Fornace Fonti riempiono l’interno di uno dei forni con le tavelle in argilla per la cottura, Rovigo, 17 settembre 2025. Antica Fornace Fonti è una delle aziende coinvolte nel progetto per la preparazione delle tavelle ricoperte di bio-intonaco da collocare nei sette siti di progetto.

Alcune tavelle ricoperte da bio-intonaco sono stoccate da Circular Venice srl nel cantiere di lavoro a Porto Viro (RO), 17 settembre 2025. Il bio-intonaco è una pasta bianca costituita da polvere di gusci di ostriche e leganti naturali. Le tavelle vengono collocate all’interno dei gabbioni metallici per costituire il substrato di attecchimento per le larve di Ostrea edulis.

Alcuni bancali pronti con tavelle ricoperte di bio-intonaco sono stoccati nel cortile dell’Antica Fornace Fonti assieme ai laterizi prodotti per strutture edilizie, Rovigo, 17 settembre 2025.
LE COSTE DEL FUTURO
Ogni sito occupa un’area di mare superiore a 4 campi da calcio e, complessivamente nei sette siti, oltre ai substrati sono state posate ad oggi 13 tonnellate di ostriche adulte e sub-adulte per la riproduzione. Ostriche che sono state approvvigionate sia da attività di pesca che di acquacoltura, sostenibili, in Adriatico.
«Uno sforzo enorme», afferma Raicevich, ma assolutamente necessario per recuperare una risorsa di tale pregio ecologico, che ha subito un declino anche per via dei cambiamenti climatici e dell’introduzione di specie aliene come l’ostrica concava, Magallana gigas, (nota anche come “ostrica del Pacifico” o “ostrica giapponese”), più rustica e a crescita rapida, che si è poi ampiamente diffusa in tutto il Mediterraneo.
Oggi si stima che oltre l’85% delle barriere coralline di molluschi sia andato perduto a livello globale e i mari europei sono tra i più colpiti. Questa situazione ha già portato a diversi progetti di ripristino in Nord Europa, come il Flat Oyster Recovery in Francia e l’Essex Native Oyster Restoration Initiative in Gran Bretagna.
Ma il più grande progetto di ripristino, ad oggi, resta sicuramente il Billion Oyster Project, nato nel 2014 da un’organizzazione no-profit di New York con lo scopo di restaurare un miliardo di ostriche native nelle acque del porto. A differenza del progetto di ripristino in Adriatico, che è finanziato da un programma governativo, il Billion Oyster Project nasce come un grande progetto di citizen science dove pezzi di barriera vengono ricostruiti coinvolgendo di volta in volta classi scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e i ristoratori di New York che forniscono i gusci di ostriche consumate dai loro avventori per essere usate come substrato.
«Le ostriche della baia di New York stanno già filtrando quasi 200 litri di acqua ogni giorno, contribuendo alla rimozione di nutrienti in eccesso come azoto e fosforo, e alla riduzione di zone ipossiche», racconta Giovanni Coppini, che nel 2024 ha visitato il Billion Oyster Project. Coppini è il Direttore del programma Global Coasts as a New Frontier (Le coste globali come nuova frontiera) del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), fondazione internazionale che si occupa di studiare l’interazione tra il cambiamento climatico e la società umana.

Una biologa della Società cooperativa M.A.R.E. misura la larghezza della valva piatta di Ostrea edulis per verificarne le dimensioni, Cattolica (RN), 23 ottobre 2025.
UN SISTEMA COSTIERO PIÙ VIVO
«Per l’Adriatico, un progetto di questo tipo potrebbe contribuire a contrastare fenomeni di eutrofizzazione, fioriture algali e degrado del fondale marino causato dall’impatto antropico e dagli scarichi costieri», aggiunge Coppini che si occupa proprio di studiare ed implementare strategie per l’adattamento costiero ai cambiamenti climatici. In un contesto come quello dell’Adriatico, infatti, le coste subiscono molteplici pressioni – innalzamento del livello del mare, eventi meteo estremi, crescita dell’urbanizzazione e aumento dei carichi di nutrienti, modifiche dei flussi costieri dei sedimenti. Il ripristino dei reef di ostrica piatta potrebbe allora integrarsi con altri interventi come il restauro delle dune, il ripristino di banchi di fanerogame e Posidonia oceanica, al fine di realizzare una più ampia strategia di adattamento.
Inoltre la biomassa vivente e le strutture calcaree delle ostriche possono contribuire a sequestrare il carbonio nel sistema marino costiero, fornendo un contributo alla mitigazione del cambiamento climatico. Secondo Coppini, quindi, «le barriere di ostrica piatta possono rendere più robusto il sistema mare-costa di fronte a shock e stress, contribuendo a una maggiore capacità di recupero e a sistemi costieri più vivi e meno vulnerabili».