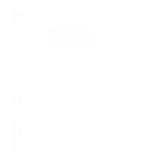Sofia Crespo, artista di origine argentina e residente a Berlino, fa parte di una corrente artistica nuova. È una corrente che unisce arte e intelligenza artificiale, ed è in rapida espansione per numero di artisti catturati dal potenziale creativo e per la velocità con cui la tecnologia digitale avanza. Ed oggi, forse anche per la pandemia che ha forzato un po’ tutti a spingere sull’acceleratore del digitale.
Questa forma d’arte in continua evoluzione – contestata da chi non la reputa vera arte – si sta posizionando in modo altrettanto stupefacente a livello commerciale. Basti pensare al Ritratto di Edmond Belamy, dipinto dall’intelligenza artificiale attraverso l’algoritmo del collettivo francese Obvious, prima opera di questo genere battuta all’asta nel 2018 da Christie’s per mezzo milione di dollari, spiazzando le previsioni che ne stimavano il valore a 10.000 dollari.
Sofia Crespo ha recentemente realizzato e tokenizzato tre delle sue opere, convertendo i diritti d’autore in un gettone digitale (token) registrato su una blockchain Ethereum (un registro digitale iper protetto) per essere vendute alla Kate Vass Galerie Digital ed esplora come l’essere umano utilizzi i meccanismi artificiali – la tecnologia appunto – per simulare se stesso ed evolvere.
arte tecnologica
Per l’artista, che studia la dinamica del ruolo degli artisti che lavorano con le tecniche di apprendimento automatico, le tecnologie sono un prodotto della vita organica che le ha create e non un oggetto completamente separato.
«Il mio interesse principale sono la vita artificiale e la biologia. Sono una continua fonte di ispirazione e di nuovi lavori».
Crespo tuttavia non utilizza necessariamente un approccio digitale per le sue opere, ma spazia dalle reti neurali artificiali (modelli computazionali composti di neuroni artificiali, ispirati alle reti neurali biologiche) ai metodi classici di stampa analogica come la cianotipia, un antico metodo di stampa fotografica a contatto, mediante raggi UV, risalente alla metà dell’800 e caratterizzata da una dominante di colore Blu di Prussia. Per l’artista generativa – che lavora ad opere che creano se stesse – la tecnologia è un mezzo per un fine che non coincide con l’impiego di una data tecnologia per il gusto di usarla, ma piuttosto per esplorare modi diversi di meditare su un soggetto, un’estetica o un messaggio.
«Per me la differenza tra una matita e una rete neurale», racconta Sofia, «è che entrambe offrono risultati stimolanti e potenziali esiti di serendipità [la scoperta di qualcosa di valore o piacevole quando meno ce lo si aspetta, nda], quindi comincio sempre chiedendomi quale sia il soggetto e l’intento artistico, poi proseguo esplorando. Non penso che qualcosa di tecnologicamente avanzato sia automaticamente migliore, dopo tutto».

Naturale e artificiale
Per Sofia Crespo è sbagliato considerare il mondo diviso in noi contro loro (riferito agli esseri umani e alle macchine), infatti questo approccio ci ha portato a considerare tutti gli oggetti tecnologici come artificiali e solo come fonte di guadagno, scollegandoli dal loro contesto e dalle possibili conseguenze sul pianeta e su di noi. L’uso di strumenti è tutt’altro che limitato ai soli esseri umani.
Nel mondo animale vediamo, tra gli altri, primati o specie aviarie usare strumenti. Quindi la tecnologia non è da considerarsi una nostra invenzione: emerge piuttosto naturalmente tra le specie che mostrano una comprensione più complessa di sé e delle conseguenze delle proprie azioni.
Sofia Crespo ha un punto di vista inclusivo sull’interazione uomo-tecnologia. «Se esaminiamo la rete di infrastrutture tecnologiche che avvolge il mondo oggi, possiamo vedere come, ad esempio, le centrali elettriche consumino risorse che a loro volta guidano e attivano una miriade di agenti digitali e fisici che interagiscono tra loro. Interazioni che non sono affatto diverse da un ecosistema o un corpo unico in cui le singole parti agiscono insieme come in un unico organismo.
Il fatto che l’influenza sulle nostre vite e le conseguenze sul pianeta di questa infrastruttura digitale siano in effetti strettamente intrecciate significa che possiamo affermare che il digitale è parte del mondo naturale e dei suoi ecosistemi. Tuttavia non siamo pronti, evidentemente, a vedere il mondo in questa prospettiva e così abbiamo preferito progettare le interfacce digitali in modo da non percepirle come parte del ciclo naturale degli ecosistemi».

Alla base dell’umano

La natura immaginata