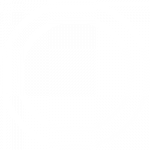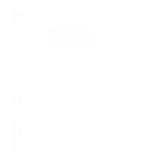L’attenta osservazione degli animali è probabilmente una tra le prime e più antiche attività praticate dagli esseri umani. Lo studio dei comportamenti, delle abitudini e delle forme erano infatti indispensabili per il buon esito della caccia e per difendersi dai predatori. Non è quindi sorprendente che le popolazioni di ogni parte del mondo possedessero informazioni zoologiche accurate molto prima della nascita di discipline come la tassonomia, l’ecologia e l’etologia. Questo insieme di conoscenze, che oggi chiamiamo etnozoologia, erano definite dagli antropologi come “tradizioni ecologiche locali”.
Quando la zoologia iniziò a essere codificata come disciplina scientifica, nell’Ottocento, i ricercatori inizialmente sottovalutarono queste conoscenze tradizionali. Le cose cambiarono, anche se lentamente, all’inizio del Novecento. Se fino ad allora l’etnozoologia era stata una branca dell’antropologia culturale relegata alle pratiche zootecniche tradizionali, nel 1914 Junius Henderson e l’etnologo John Peabody Harrington ne ridefinirono il concetto come «lo studio delle culture esistenti e delle loro relazioni con gli animali negli ambienti circostanti».
Informazioni di valore dall’etnozoologia
L’integrazione delle scienze sociali all’interno della ricerca zoologica ha storicamente rappresentato un ostacolo. Sia perché i biologi da campo non sono, di norma, formati su questi aspetti, sia per il fatto che le categorie etnozoologiche non sempre combaciano con quelle della scienza occidentale. In più occasioni, per esempio, animali che erano considerati dai nativi come specie distinte si sono poi rivelati sessi, o diverse fasi della crescita, all’interno di una stessa specie.
Attualmente, le attività umane stanno erodendo gli habitat naturali a ritmi vertiginosi. La perdita di biodiversità a cui stiamo assistendo è in grado di portare all’estinzione una moltitudine di specie ancora prima che possano essere scoperte. In questo contesto, in chi fa ricerca in zoologia sta crescendo la consapevolezza che qualunque fonte di informazione può assumere un valore inestimabile, e i successi dovuti alle tradizioni locali e all’etnozoologia sicuramente non mancano.
Nel 2010 Tyrone Lavery, biologo del Museo di Storia Naturale di Chicago, si trovava sull’isola di Vangunu, arcipelago delle Salomone, sulle tracce di un misterioso roditore conosciuto con il nome di vika dai nativi. Precedentemente Lavery si era imbattuto in una relazione del 1995 dell’antropologo Edvard Hviding, nella quale era descritto “un ratto molto grande divoratore di cocchi” e aveva così deciso a scoprire se si trattasse in realtà di un nome locale del ben noto ratto nero (Rattus rattus) o di una specie non ancora documentata. Ma nonostante un’estensiva ricerca tramite trappole per roditori, transetti notturni e fototrappole, aveva lasciato l’isola senza ottenere nessuna prova concreta dell’esistenza dell’animale.
Poi, nel 2016, in seguito al taglio di una dillenia (Dillenia solomonensis) per fini commerciali, i nativi con cui Lavery aveva lavorato si accorsero che un vika lungo quasi 50 cm era precipitato dalla pianta riportando ferite letali. L’esame del cranio e l’analisi del DNA confermarono in seguito lo status di nuova specie, la prima di roditore descritta dopo oltre 80 anni nelle Isole Salomone, che venne battezzata Uromys vika.
LEGGI ANCHE: I maori, una nuova guida per l’Antartide
Varani elusivi
Anche specie ben più grandi sono state di recente scoperte grazie all’apporto dei nativi e dell’etnozoologia. Un esempio incredibile arriva da Luzon, la più grande isole delle Filippine. Qui, nel 2001, alcuni biologi si imbatterono per puro caso in gruppi di cacciatori delle tribù Agta e Ilongot che stavano trasportando cadaveri di varani di grandi dimensioni e dall’aspetto insolito. Negli anni precedenti, alcuni etnozoologi avevano raccolto informazioni riguardanti varani chiamati bitatawa e butiwak dai cacciatori nativi, e da loro descritti come arboricoli, frugivori e… buoni da mangiare. Motivo per cui non fu possibile convincerli a donare campioni degli animali.
In seguito, l’erpetologo Arvin Diesmos del Museo Nazionale delle Filippine e il suo staff continuarono a indagare sul campo, senza però riuscire a entrare in possesso di un esemplare. L’impresa riuscì soltanto nel 2009 a un team di ricerca guidato da un altro erpetologo, Rafe Brown dell’Università del Kansas, quando dei cacciatori nativi portarono il cadavere di un bitatawa al loro campo base.
Così, i ricercatori appresero come, nonostante dimensioni che possono raggiungere i due metri coda compresa e una vistosa livrea nera e gialla, il Varanus bitatawa non fosse facile da osservare. All’avvicinarsi di un pericolo, il rettile era infatti abituato a fuggire sugli alberi e a nascondersi tra la vegetazione.
Tiro a segno
Un altro aspetto affascinante delle conoscenze ecologiche locali riguarda informazioni sul comportamento di specie note. Nel 1865, l’esploratore artico Charles Francis Hall pubblicò un resoconto riferitogli dagli inuit, riguardante un orso polare (Ursus maritimus) dell’isola di Baffin in Canada, che aveva attaccato un tricheco (Odobenus rosmarus) lanciandogli contro una pietra.
La tradizione secondo cui gli orsi polari sono in grado di utilizzare strumenti durante la caccia è molto radicata tra le popolazioni locali, ma gli zoologi avevano sempre respinto con forza queste testimonianze. Le cose sono cambiate nel mese di giugno del 2021, quando la rivista Arctic ha pubblicato una revisione a cura di Ian Stirling, biologo dell’Università dell’Alberta. Stirling ha analizzato i resoconti inuit degli ultimi 200 anni concludendo che, sebbene sia un comportamento raro, è probabile che questi animali siano perfettamente in grado di attuarlo.
Lo studio ha vagliato racconti di seconda mano, testimonianze dirette e pubblicazioni scientifiche, raccogliendo informazioni molto interessanti, tra le quali anche segnalazioni sul campo da parte di ricercatori. Tra queste c’era quella di Charles Jonkel, esperto di orsi dell’Università del Montana, che nel 1971 si accorse che alcuni orsi polari avevano utilizzato delle pietre, lanciandole da due metri di distanza, per disinnescare delle trappole a laccio e cibarsi dell’esca evitando di essere catturati.
Esistono poi anche episodi documentati fotograficamente, che risalgono al 2010: hanno come protagonista un orso polare maschio di 5 anni chiamato GoGo, ospitato presso lo zoo di Osaka. Nelle immagini, scattate dal giornalista Hyroiuki Hueba, si vede GoGo in azione mentre utilizza strumenti di vario tipo per raggiungere del cibo, sia lanciando oggetti, sia utilizzando tronchi e bastoni, dimostrando un grado eccezionale e precedentemente non documentato di creatività concettuale per facilitare l’accesso a un alimento appeso in aria.
LEGGI ANCHE: Come è nato il mito della Groenlandia verde
I falchi del fuoco: tra mito ed etnozoologia
Il più impressionante esempio di utilizzo deliberato di strumenti da parte di animali documentato dai nativi proviene però dall’Australia. Benché sia famosa per le sue spiagge e i suoi deserti, l’Australia vede il 20% del suo immenso territorio occupato da savane tropicali, adattate ai piccoli incendi. Gli aborigeni tramandano da generazioni l’utilizzo del fuoco sia per cacciare, sia per limitare l’estensione degli incendi naturali, permettendo di salvaguardare la vegetazione. Alcuni gruppi dell’Australia settentrionale, come gli Alawa e i MalakMalak, raccontano che questa conoscenza fu insegnata loro da uccelli chiamati falchi del fuoco.
Si sa da tempo che i rapaci possono approfittare degli incendi naturali che, causando la fuga di insetti, roditori e rettili, facilitano la cattura delle prede. Uno studio pubblicato nel 2017 sulle pagine della rivista Journal of Ethnobiology, però, ha portato la nostra conoscenza di questo fenomeno a un altro livello. Infatti, un team di ricercatori guidati da Mark Bonta e Robert Gosford rese noto che uccelli come il nibbio bruno (Milvus migrans), il nibbio fischiatore (Haliastur sphenurus) e il falco bruno (Falco berigora), sembrano in grado di trasportare intenzionalmente legni infuocati nel becco e tra gli artigli per diffondere il fuoco.
Come nel caso precedente, gli autori non si sono limitati a vagliare le conoscenze e le tradizioni dei nativi, ma hanno anche raccolto testimonianze dirette, alcune delle quali registrate da loro stessi. Questi casi hanno per protagonisti singoli individui, ma anche esemplari che sono stati visti collaborare assieme. I rapaci sembrano in grado non solo di sfruttare incendi già in atto, ma anche di rialimentare incendi prossimi allo spegnimento e di sfruttare come innesco il fuoco da campo e dei falò realizzati dagli esseri umani.