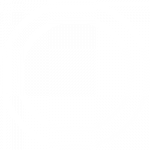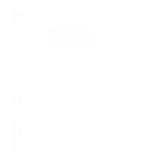Robert Bilott è la persona che più di tutte ha fatto sì che la contaminazione globale da PFAS diventasse nota al grande pubblico. La sua storia legata alle sostanze poli e perfluoroalchiliche ha inizio negli anni ‘90, quando incontrò Wilbur Tennant, un agricoltore di Parkersburg, in West Virginia. Il bestiame di Tennant stava morendo senza alcun motivo apparente e la sua fattoria si trovava a poca distanza dalla discarica usata dall’azienda DuPont per scaricare tonnellate di PFOA. Nel 1999 Robert Bilott intentò causa all’azienda e diede il via a un processo che, quasi vent’anni dopo, stabilì le responsabilità di DuPont e i relativi risarcimenti alla cittadinanza.
Le vicende di Robert Bilott e della sua lotta contro i PFAS sono state raccolte nell’autobiografia dal titolo “Exposure”, da cui è stato tratto il film “Cattive acque”, con Mark Ruffalo nei panni di Robert Bilott e Anne Hathaway in quelli di sua moglie, Sarah Barlage Bilott. Oggi Robert Bilott è impegnato anche in una intensa attività di comunicazione al pubblico e condivisione delle sue conoscenze sul tema dei PFAS.
A maggio 2023 l’avvocato nato ad Albany ha intrapreso un viaggio in Italia, per incontrare le comunità afflitte dal gravissimo caso di contaminazione da PFAS provocato dall’azienda MITENI, in provincia di Vicenza. Durante la sua permanenza, Robert Bilott è stato ascoltato dalla corte del Tribunale di Vicenza – dove si svolge il processo contro alcuni ex dirigenti di MITENI – in quanto persona informata sui fatti.
Abbiamo seguito Robert Bilott nel corso del suo viaggio e lo abbiamo intervistato. Il colloquio si è svolto durante il tragitto che dal Tribunale porta all’abitazione della famiglia di attivisti che ha ospitato l’autore di questa intervista, il fotografo Stefano Schirato e lo stesso Robert Bilott. Il morale è basso: la prima udienza di Robert Bilott, prevista per il 23 maggio, si è risolta con un nulla di fatto. La persona incaricata di tradurre dall’inglese all’italiano (e viceversa) aveva una scarsa conoscenza della lingua inglese, incompatibile con il ruolo di interprete. Di conseguenza il giudice è stato costretto a rinviare di due giorni l’audizione di Robert Bilott, tra l’ilarità sarcastica delle persone presenti in aula.
Robert Bilott, quali sono le strategie utilizzate dagli avvocati che difendono i produttori di PFAS?
«Una delle strategie più comuni è stata, fin dall’inizio, quella di mettere in discussione le evidenze scientifiche e il rapporto tra l’esposizione ai PFAS e le ricadute sulla salute. Le grandi aziende produttrici si oppongono alle richieste di risarcimento, affermando che non ci siano prove sufficienti per dimostrare un rapporto di causa/effetto. È una strategia che si è ripetuta fin dal primo giorno e che è usata ancora oggi: negare la scienza oppure cercare di screditarla invece che discutere a partire dai fatti. È così che hanno tentato di ottenere sconti sulle pene».

Robert Bilott, 58 anni, avvocato statunitense, seduto nell’aula del Tribunale di Vicenza, nell’ambito del processo alla Miteni SPA.
Ha mai osservato un distacco privo di empatia da parte dei dirigenti d’azienda chiamati a deporre?
«Sì, sicuramente. Nei casi a cui ho lavorato, ho visto che in tutta la catena di comando – in tutte le persone che penseresti abbiano la responsabilità di prendere decisioni – c’è un costante tentativo di minimizzare la quantità di informazioni in proprio possesso. Ho sentito spesso dire “non mi occupavo di questo tema”, “non era un argomento di mia competenza”, “non sapevo cosa stessero facendo le altre persone all’interno dell’azienda”. La possiamo definire una sorta di ignoranza intenzionale nei confronti di ciò che accade sul luogo di lavoro.
È un fenomeno che ho osservato, per esempio, quando ascoltavo l’amministratore delegato di DuPont mentre affermava in modo categorico che “non abbiamo prove che questa sostanza chimica sia dannosa”. Più lo guardavo e più mi convincevo che forse quell’uomo non doveva mai avere visto i documenti che l’azienda, in realtà, aveva. Di conseguenza, il mio obiettivo, quando raccoglievo la sua deposizione, non era quello di cercare di imparare qualcosa da lui, ma di assicurarmi che vedesse i documenti e gli studi che ritenevo l’azienda stesse cercando di nascondergli. Il motivo era semplice: una volta che il responsabile delle decisioni avesse visto tutto ciò, non avrebbe più potuto affermare in pubblico che “non abbiamo le prove”.
Dopo quella deposizione le cose sono cambiate e il caso si è risolto non molto tempo dopo. Ho visto più e più volte che erano in atto dei tentativi per assicurarsi che certe persone non sapessero ciò che stava accadendo. È anche per questo motivo che è importante garantire che tutte le prove e i documenti siano disponibili a chiunque».
Cosa l’ha spinta a intraprendere questo viaggio nei “luoghi simbolo” della contaminazione da PFAS?
«Abbiamo passato 25 anni a raccogliere informazioni e documenti riservati per capire esattamente cosa stesse succedendo e quali aziende – pur sapendo che i PFAS fossero pericolosi – hanno continuato comunque a produrli. Voglio assicurarmi che queste informazioni siano disponibili per le persone che in altri luoghi hanno a che fare con le stesse sostanze chimiche. È ciò che sta accadendo in Italia, dove è abbastanza chiaro che chi aveva capito che cosa stava accadendo ha continuato imperterrito a tacere la verità».
LEGGI ANCHE: Come è nata l’emergenza PFAS in Veneto
In Veneto il fronte dell’attivismo si muove compatto e organizzato. Ha osservato movimenti popolari simili in altri paesi?
«In Veneto ci sono persone che sono vittime della contaminazione, persone che hanno bevuto quest’acqua, i cui figli l’hanno bevuta per anni, se non decenni. Da tempo ormai queste persone si sono alzate in piedi per gridare che tutto ciò è sbagliato e non dovrebbe accadere. Ma queste stesse persone hanno la forza e la possibilità di fermare tutto ciò, di affrontarlo e di assicurare una vita sana per sé e per i propri cari. Vediamo comunità del genere in tutto il mondo, non solo in Italia. La cittadinanza si organizza anche in Giappone, negli Stati Uniti e in Australia.
Credo che le persone si stiano rendendo conto di avere un potere incredibile quando si riuniscono e fanno sentire la loro voce. E questo è uno dei motivi per cui abbiamo voluto realizzare il film Dark Waters o il documentario The Devil We Know. Una comunità che si avvicina e si unisce si scontra con la potente realtà aziendale, dotata di molte risorse. È un compito difficile, senza dubbio, e potrebbe richiedere molto tempo, ma si può fare. Ci sono molti modi per diffondere le informazioni e fare in modo che i funzionari pubblici inizino ad agire. Lo stiamo vedendo accadere in tutto il mondo».

Elisabetta Donadello, attivista, e Robert Bilott, avvocato statunitense, discutono del progetto che l’Università di Padova sta portando avanti, nell’appezzamento di terra di Elisabetta, per lo studio dei PFAS nei prodotti dell’orto. Vicenza.
Quantomeno in Occidente, si dibatte molto sui PFAS a catena corta, i prodotti che sostituiscono sostanze ormai bandite come PFOA e PFOS. I composti a catena corta sono presentati dalle aziende come sicuri. Tuttavia, sono le stesse aziende che affermano che anche i PFAS di nuova generazione saranno gradualmente eliminati. È un comportamento contraddittorio?
«Sì. Al principio avevamo scoperto la pericolosità di PFAS con una catena a otto atomi di carbonio, i famigerati “C8” come il PFOA e il PFOS. Quando il problema è emerso, la comunità scientifica e molte autorità di regolamentazione di tutto il pianeta hanno iniziato finalmente a interessarsi. A quel punto le aziende hanno annunciato che non avrebbero più prodotto tali sostanze e che le avrebbero sostituite. Tuttavia, era chiaro fin da subito, si trattava di semplici modifiche della stessa identica sostanza: hanno tolto o aggiunto atomi di carbonio alla stessa struttura chimica. Le aziende hanno quindi impiegato queste “nuove” sostanze negli stessi prodotti in cui era presente il C8. Ma questa sostituzione è avvenuta senza fare tutti i test per determinare se i nuovi composti fossero davvero più sicuri del C8.
Soltanto dopo che le sostanze sostitutive sono entrate nel mercato si è cominciato a studiarle. Per esempio, il primo studio condotto sulle sostanze a sei atomi di carbonio (C6) ha dimostrato che possono provocare gli stessi tre tumori di cui è responsabile il C8. Ma a quel punto è troppo tardi: le sostanze nuove sono già in circolazione e sono molteplici. C4, C9, C10 sono prodotti in tutto il mondo. Le autorità vedono che sono prodotti tecnicamente diversi ma hanno gli stessi identici problemi di tossicità, persistenza e bioaccumulo. È per questo che non si può più procedere “una sostanza alla volta”: immetterla sul mercato, analizzarla, scoprire che è pericolosa e, infine, bandirla. È necessario un bando dell’intera classe PFAS, frutto di un approccio il più precauzionale possibile».
Le aziende che producono PFAS usano spesso l’economia come deterrente. Una delle affermazioni ricorrenti è “se chiudessimo la fabbrica, la gente perderebbe il lavoro e l’economia di un territorio si troverebbe in grave difficoltà”. È mai successo qualcosa di simile?
«Ci sarà sempre un impatto economico derivato dalla regolamentazione di sostanze chimiche tossiche come i PFAS. Ma è più importante dare la priorità ai possibili impatti economici o a quelli accertati sulla salute pubblica? È questa la domanda che dovremmo farci. La realtà è che siamo già riusciti a regolamentare e limitare i PFAS e nessuno ha mai costretto le aziende a chiudere».
Lei ha dedicato 25 anni della sua vita – un quarto di secolo – ai PFAS. Lei e il suo staff vi siete posti un obiettivo finale?
«Gli obiettivi, soprattutto quando si parla di sostanze come i PFAS, possono evolversi nel tempo. Quando sono stato coinvolto per la prima volta, non avevo nemmeno idea dell’esistenza dei PFAS. Al principio, nel 1998, quando ho accettato di occuparmi del caso di Wilbur Tennant, l’agricoltore della West Virginia, non avevo idea che avrei avuto a che fare con una sostanza chimica non regolamentata. Ma, man mano che il caso andava avanti, e più documenti e più informazioni riuscivo a raccogliere, mi rendevo conto della portata e delle dimensioni del caso che stavamo affrontando. Non si trattava più di un solo agricoltore della West Virginia o di una sola città, ma di una sostanza chimica che faceva parte di un’enorme famiglia di composti completamente non regolamentati in tutto il mondo, e utilizzati in una vasta gamma di prodotti diversi.
Queste sostanze, usate da 70 anni da una moltitudine di aziende in tutto il pianeta, si sono riversate nell’aria, nel suolo e nell’acqua e hanno contaminato l’intero pianeta e ogni sua creatura, compresi gli esseri umani. Le aziende produttrici di PFAS sapevano perfettamente che queste sostanze avrebbero potuto contaminare pressoché qualsiasi cosa, ma hanno continuato a produrle lo stesso. Poco dopo avere iniziato a occuparmi dei PFAS, mi ero reso conto che io e i miei colleghi eravamo le uniche persone, al di fuori delle aziende, a essere al corrente della pericolosità dei composti florurati. Le aziende, inoltre, si sono subito impegnate attivamente in una campagna finalizzata a nascondere o a contraddire i dati, per poi arrivare a sostenere in pubblico che non c’era alcun problema. È per questi due motivi che ho sentito il dovere di rendere pubbliche tutte le informazioni che avevamo raccolto.
Negli ultimi decenni abbiamo provato a diffondere conoscenza in molti modi diversi. Dapprima agivamo come semplici avvocati, presentando memorie e argomentazioni in tribunali. Ma vedevamo che il nostro “messaggio” non arrivava né alle autorità, né alla comunità scientifica, né al pubblico. A quel punto abbiamo cominciato a contattare direttamente le autorità per far capire loro che cosa stava accadendo. Nel frattempo, le aziende cercavano di fermarci e chiedevano con forza l’obbligo di non pubblicazione del materiale a nostra disposizione. Ma siamo riusciti a pubblicarlo lo stesso e, subito dopo, abbiamo contattato media, sceneggiatori e autori cinematografici che potessero aiutarci a ordinare e diffondere tutte le informazioni in nostro possesso.
Durante l’intero processo, ci siamo resi conto che i PFAS costituiscono una enorme minaccia per la salute pubblica e per l’ambiente. Questa minaccia rischiava di passare del tutto inosservata. Ci è voluto molto tempo per far conoscere al pubblico quanto sia grave il problema dei PFAS, ma ora ce l’abbiamo fatta e in tutto il mondo osserviamo come le persone stiano diventando sempre più consapevoli della gravità della situazione. Soltanto ora le autorità e i legislatori iniziano a intervenire e a prendere provvedimenti per proteggere le persone».
L’approccio quindi dovrebbe essere sistemico, globale. Come?
«Stiamo parlando di sostanze chimiche che non si fermano davanti ai confini nazionali. Anche se decidiamo di non produrle più negli Stati Uniti, le produrranno da qualche altra parte. Una volta immessi nell’ambiente, i PFAS si spostano per lunghe distanze, basti pensare che li ritroviamo anche nella pioggia. Vanno assolutamente evitate le argomentazioni oggi utilizzate dalle autorità governative, ovvero il regolamentare i PFAS a livello nazionale e non globale, perché in questo modo l’azienda non farebbe altro che spostarsi, con le temute conseguenze sull’economia di cui abbiamo già parlato.
È necessario, invece, far capire che i PFAS non devono essere prodotti da nessuna parte. Io non so quale sia il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo istituzioni come le Nazioni Unite, ma non tutti i paesi del mondo esprimono una posizione comune contro i PFAS, come, per esempio, gli Stati Uniti. Al momento ci auguriamo che la consapevolezza pubblica diventi globale e che, a quel punto, un gigantesco numero di persone inizi a chiedere di eliminare i PFAS da qualsiasi prodotto».
Hai dei rimorsi?
«Vorrei avere prestato più attenzione alle parole del signor Tennant. Avrei dovuto ascoltarlo fin da subito. Mi ci è voluto molto tempo per capire a che cosa mi trovavo di fronte e, francamente, nel 1999 ero ancora un po’ scettico nei confronti di ciò che Wilbur Tennant mi raccontava: non potevo credere che stesse accadendo una cosa del genere, che un’azienda potesse fare una cosa simile e in maniera intenzionale. Avrei voluto realizzare ciò che stava accadendo molto tempo prima».

Robert Bilott, 58 anni, avvocato statunitense, entra nell’aula del Tribunale di Vicenza, mentre viene chiamato davanti alla Corte d’assise nell’ambito del processo alla Miteni SPA.
Come ci giudicheranno gli esseri umani del futuro?
«Probabilmente si chiederanno perché ci abbiamo messo così tanto tempo ad aprire gli occhi, vedere ciò che avevamo davanti, capire di cosa si trattasse e prendere dei provvedimenti. Quando l’intera vicenda dei PFAS sarà Storia, l’umanità avrà capito che certe cose non possano più accadere. È a loro, all’umanità del futuro, che dico: abbiate fiducia nei vostri mezzi e non fatevi confondere o distrarre da coloro che hanno come unico interesse il profitto».
Leggi la nostra inchiesta sulla contaminazione da PFAS
Questa inchiesta è parte di The Forever Pollution Project, un’indagine crossborder a cui hanno partecipato 18 redazioni da tutta Europa. Un gruppo che oltre a RADAR Magazine include Le Monde (Francia), Süddeutsche Zeitung, NDR e WDR (Germania), The Investigative Desk e NRC (Paesi Bassi) e Le Scienze (Italia), e a cui si sono aggiunti Datadista (Spagna), Knack (Belgio), Deník Referendum (Repubblica Ceca), Politiken (Danimarca), Yle (Finlandia), Reporters United (Grecia), Latvijas Radio (Lettonia), SRF Schweizer Radio und Fernsehen (Svizzera), Watershed e The Guardian (Regno Unito).